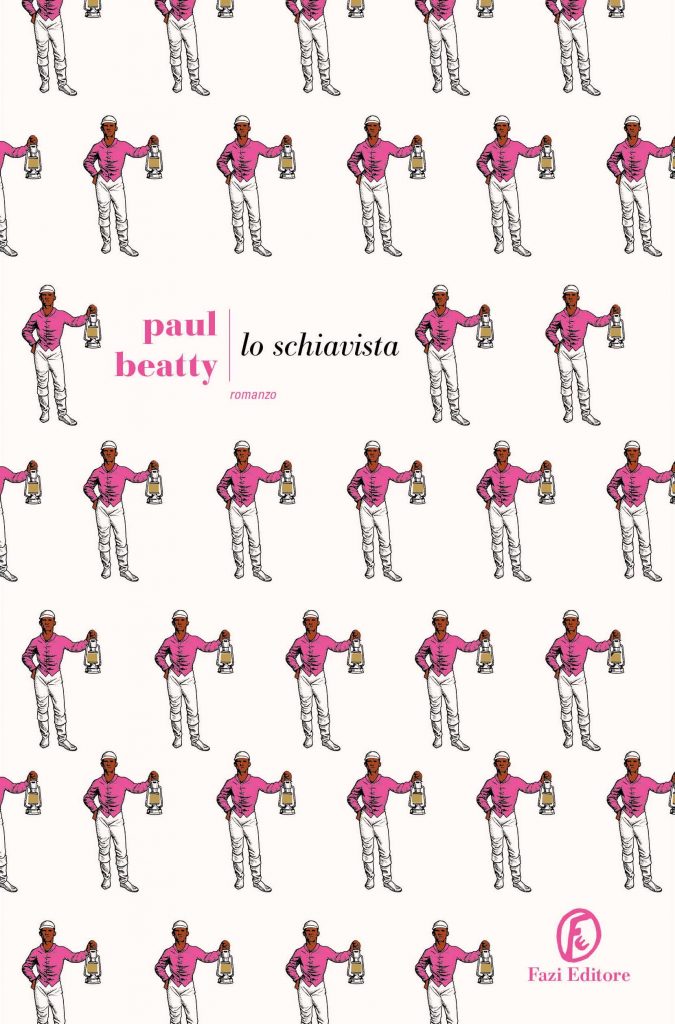
Paul Beatty: Lo schiavista, Lo schiavista, Fazi
Risvolto
«So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente. Non ho mai evaso le tasse, non ho mai barato a carte. Non sono mai entrato al cinema a scrocco, non ho mai mancato di ridare indietro il resto in eccesso a un cassiere di supermercato».
Questo l’inizio della storia di Bonbon. Nato a Dickens – ghetto alla periferia di Los Angeles – il nostro protagonista è rassegnato al destino infame di un nero della lower-middle-class. Cresciuto da un padre single, controverso sociologo, ha trascorso l’infanzia prestandosi come soggetto per una serie di improbabili esperimenti sulla razza: studi pionieristici di portata epocale, che certamente, prima o poi, avrebbero risolto i problemi economici della famiglia. Ma quando il padre viene ucciso dalla polizia in una sparatoria, l’unico suo lascito è il conto del funerale low cost. E le umiliazioni per Bonbon non sono finite: la gentrificazione dilaga, e Dickens, fonte di grande imbarazzo per la California, viene letteralmente cancellata dalle carte geografiche. È troppo: dopo aver arruolato il più famoso residente della città – Hominy Jenkins, celebre protagonista della serie Simpatiche canaglie ormai caduto in disgrazia –, Bonbon dà inizio all’ennesimo esperimento lanciandosi nella più oltraggiosa delle azioni concepibili: ripristinare la schiavitù e la segregazione razziale nel ghetto. Idea grazie alla quale finisce davanti alla Corte Suprema.
Una satira pungente sulla razza, la vita urbana e la giustizia sociale. Un’esplosione di comicità, provocazione e prosa brillante da uno degli scrittori più audaci d’America, che con questo romanzo si è aggiudicato il National Book Critics Circle Award 2016 ed è stato incluso nella rosa dei finalisti del Man Booker Prize 2016.
“Sono lo scrittore nero che vi fa ridere dei bianchi”
 racconta in chiave paradossale le vicende di un nero pieno di guai che vuole ripristinare la segregazione nella cittadina natale, generando un caso legale che viene discusso dalla Corte Suprema: non a caso il titolo originale, meno diretto ma molto più evocativo, è The Sellout, ovvero Svendersi. Una storia che è specchio di un’America realistica quanto allucinata, in cui ogni sorriso rivela angoscia e rabbia. Questo approccio è evidente sin dall’incipit («So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente») e si rafforza lungo l’evoluzione di una vicenda che mette insieme sarcasticamente tutti gli stereotipi sugli afroamericani. La critica è entusiasta: c’è chi ha definito Lo Schiavista un «capolavoro della satira degno di Swift». «Sono complimenti che riempiono di gioia» racconta Beatty, dal suo appartamento dell’East Village di New York, «anche se i miei reali riferimenti sono più moderni: leggo e amo Joseph Heller e Kurt Vonnegut ».
racconta in chiave paradossale le vicende di un nero pieno di guai che vuole ripristinare la segregazione nella cittadina natale, generando un caso legale che viene discusso dalla Corte Suprema: non a caso il titolo originale, meno diretto ma molto più evocativo, è The Sellout, ovvero Svendersi. Una storia che è specchio di un’America realistica quanto allucinata, in cui ogni sorriso rivela angoscia e rabbia. Questo approccio è evidente sin dall’incipit («So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente») e si rafforza lungo l’evoluzione di una vicenda che mette insieme sarcasticamente tutti gli stereotipi sugli afroamericani. La critica è entusiasta: c’è chi ha definito Lo Schiavista un «capolavoro della satira degno di Swift». «Sono complimenti che riempiono di gioia» racconta Beatty, dal suo appartamento dell’East Village di New York, «anche se i miei reali riferimenti sono più moderni: leggo e amo Joseph Heller e Kurt Vonnegut ».Se in Slumberland buona parte della trama si svolgeva in Europa, per la precisione a Berlino negli anni della caduta del muro, il setting dello schiavista è Dickens: una minuscola cittadina della Los Angeles Area fondata nel secondo ottocento come comunità agricola, per poi trasformarsi in un ghetto per neri e finire cancellata dalla gentrification. Ed è proprio per ribellarsi contro l’obliterazione della città in cui è nato che il protagonista, Bonbon Me – già segnato dall’uccisione del padre sociologo da parte della polizia – comincia la sua personale guerra contro il governo degli Stati Uniti: prima ridisegnando i confini di Dickens con la vernice bianca; poi cercando di reintrodurre la segregazione razziale – in fondo, non c’è niente di meglio dell’apartheid per restaurare un senso di comunità tra gli afroamericani – e ficcandosi così nel gigantesco pasticcio che lo porterà davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti (dove lo troviamo nel lungo, esilarante prologo del romanzo).
BonBon Me è un personaggio sui generis: se tenta di farsi strada nella vita non è nel nome di un desiderio di autoaffermazione razziale, ma tutt’al più assecondando la «frenesia edipica di compiacere il padre». Il suo rapporto con l’identità afroamericana viene formulato con la massima chiarezza in uno dei primi capitoli dello Schiavista: «Ora, se dipendesse solo da me, non potrebbe importarmene di meno di essere nero. A tutt’oggi quando mi arriva per posta il modulo dell’anagrafe, sotto la voce «Razza» barro la casella «Altro» e nello spazio accanto scrivo orgogliosamente «californiano».
Naturalmente due mesi dopo un impiegato dell’anagrafe si presenta a casa mia, mi dà un’occhiata e dice: «Razza di sporco negro. In quanto nero, cos’hai da dire a tua discolpa?». E in quanto nero, non ho mai niente da dire a mia discolpa. Quindi ho bisogno di un motto: se lo avessimo, alzerei il pugno, lo griderei forte e sbatterei la porta in faccia al governo. Ma non ce l’abbiamo. Perciò borbotto: «Mi scusi», e scarabocchio le mie iniziali accanto alla casella con la scritta “Nero, afroamericano, vigliacco”». Questo improbabile antieroe si fa portatore di un progetto paradossale, una sorta di antiutopia che, pure, ha una sua ragione profonda. Nel decimo capitolo dello Schiavista, BonBon mette in scena, sull’autobus guidato dall’ex amore della sua vita, Marpessa, la versione invertita di «quel giorno d’inverno nello Stato segregazionista dell’Alabama», in cui Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un bianco. Incolla sotto i finestrini cartelli a caratteri bianchi e azzurri: «Posti riservati agli anziani, ai disabili e ai bianchi».
Passati in rassegna i mille episodi che, nel corso del Novecento, hanno fatto di Los Angeles l’epitome del razzismo americano (dall’internamento di massa dei nippoamericani, evocato recentemente da James Ellroy in Perfidia, agli urban riots del 1992, seguiti al brutale pestaggio di Rodney King da parte della polizia), BonBon chiarisce la sua visione della storia degli Stati Uniti: l’integrazione etnica – come del resto quella sociale – si è rivelata un autentico fallimento, e agli afroamericani non resta che l’autoghettizzazione come scelta e paradossale diritto.
In un paese sconvolto dalla recrudescenza del conflitto razziale già in corso quando Lo schiavista è stato scritto, e che diventa ogni giorno più evidente, Beatty torna a sfruttare, con maturità ormai piena, le armi e le tecniche di racconto a lui più congeniali: fonde la tradizione umoristica afroamericana e quella satirica che da Twain passa per Vonnegut e approda a Saunders. E costruisce un edificio narrativo denso di riferimenti storici e culturali, a volte quasi sovraccarico, ma che sa illuminare, con leggerezza profonda, i contrasti e gli abissi di una società in declino.
La prosa sotterranea dell’apartheid
Personalmente non ho mai creduto che il colore della pelle del presidente degli Stati Uniti potesse cambiare in profondità le cose nel paese, una situazione che per certi versi si protrae da alcuni secoli. Ed in realtà, al di là delle enunciazioni di principio e al valore simbolico di quell’evento, nessuno ha mai pensato che con l’arrivo di Obama alla Casa Bianca il razzismo potesse essere scomparso, anche perché in molti hanno continuano a viverlo ogni giorno sulla propria pelle, come dimostra la violenza di cui tanti giovani neri sono rimasti vittime proprio in questi ultimi anni. Piuttosto ciò a cui si è assistito è una sorta di rimozione del problema dallo spazio pubblico, quasi fosse diventato inopportuno il semplice nominare tali fenomeni.
Visto che un nero era diventato presidente non era più il caso di parlare dell’eredità della segregazione o dell’apartheid sociale che ha preso il posto del vecchio suprematismo bianco?
Qualcosa del genere. Ripeto, il problema è stato semplicemente rimosso, al punto che per molti giovani è come se non fosse quasi mai esistito. Alla Columbia University, dove insegno, mi sono trovato spesso a parlare con studenti che sembrano non vedere come i meccanismi del razzismo siano ancora pienamente attivi nel mondo che li circonda; e questo perché oggi è come se fosse considerato politicamente scorretto il solo parlare della questione. Molti dei miei studenti sono infatti convinti che citare le discriminazioni, non solo razziali ma anche di genere o di classe, rappresenti quasi un modo subdolo per alimentarle. Con il risultato che il clima sociale e culturale «costruito» nell’ultimo decennio rischia spesso di rendere indicibile, non più descrivibile fino in fondo ciò che si vive ogni giorno, la realtà concreta e profonda del paese.
Le faccio un esempio: un giorno stavo parlando con un mio collega messicano e con un nostro studente il quale ad un certo punto ci si è rivolto dicendo: «Mi dispiace davvero tanto per voi due perché per voi deve essere stato davvero difficile avere a che fare per tanti anni, quando eravate giovani, con il razzismo e con tutti i problemi che può avervi provocato». Io e il mio collega ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere perché al contrario pensiamo che sia molto più difficile per le nuove generazioni misurarsi con tutto questo. Noi avevamo una serie di strumenti per leggere la società che ci permettevano di analizzarla e di affrontarne i nodi più problematici che spesso oggi, proprio per il clima che ho descritto, sembrano mancare del tutto ai più giovani.
Perciò è per «dare un nome alle cose», per ricordare come la discriminazione razziale non abbia smesso di essere presente nella società americana che nel suo romanzo ricorrere al paradosso di un nero che vuole ripristinare schiavitù e segregazione?
In primo luogo ho voluto sottolineare come negli Stati Uniti da questo punto di vista i fantasmi del passato continuino ad influenzare il presente. Dico questo perché non solo si tende a rimuovere la storia della schiavitù e della segregazione dalla memoria collettiva del paese, quasi fosse difficile semplicemente riflettere sulle conseguenze di tutto ciò, ma addirittura negli ultimi anni sta emergendo anche una sorta di nostalgia per i «vecchi tempi» in cui il paese era più ordinato e tranquillo, quando «ognuno stava al suo posto» e i confini culturali e morali, ma anche implicitamente razziali, erano netti, tracciati in modo chiaro.
È questo un fenomeno che evoca in modo più o meno esplicito se non gli anni dello schiavismo, quelli della segregazione razziale, e che trova consenso sia tra molti bianchi che tra i neri di destra che sostengono che un tempo le famiglie nei ghetti erano più solide e «la comunità» era unita. Che non si tratti di una tendenza marginale lo hanno del resto confermato le elezioni presidenziali. Lo slogan della campagna di Donald Trump promette infatti di «far tornare grande l’America», strizzando apertamente l’occhio alla crescente nostalgia di un paese in cui le gerarchie tradizionali di razza come di genere erano ancora ben salde.
Proprio Trump si è però presentato anche come l’uomo che avrebbe detto la verità al paese, prendendo di mira il politicamente corretto che a suo dire rappresenta una sorta di linguaggio del potere per nascondere la realtà delle cose. In questo senso gli ambienti progressisti non hanno capito la portata della minaccia?
Personalmente ho sostenuto Bernie Sanders e sono sempre stato convinto che con Hillary Clinton presidente per il paese, ed i neri in modo particolare, le cose non sarebbero migliorate granché. Oggi è però chiaro che con Trump alla Casa Bianca la situazione non farà che peggiorare. Durante la campagna elettorale ho percepito, anche parlando con le persone che conosco a New York che è per altro una città molto liberal, quanto rabbia e paura stessero diventando i sentimenti dominanti, il risultato delle urne ha poi confermato, ma oltre ogni possibile previsione, questa sensazione.
Quanto al dibattito sul politicamente corretto voglio essere chiaro: non credo che si tratti di qualcosa di negativo quando serve per esprimere rispetto e volontà di inclusione nei confronti di chi è diverso da noi. Da questo punto di vista la strategia adottata da Trump al riguardo è stata in realtà un bluff, nel senso che per la sua parte politica e per le persone cui si è rivolto è tutt’altro che «scorretto» dire le cose che ha detto riguardo agli immigrati messicani, ai musulmani o alle donne. Lui ha detto voce a posizioni e idee che nel paese hanno una forza evidente, e questo a prescindere dalla sua candidatura. Semmai è nel non capire il malessere di una parte della popolazione che i progressisti hanno mostrato tutti i loro limiti.
In quest’ultimo romanzo come nei suoi libri precedenti, «Slumberland» e «American Prophet», sembra emergere però anche la volontà di smontare alcuni luoghi comuni della memoria afroamericana, a partire dalla stessa definizione di «comunità nera» che non si capisce bene se sia frutto di una consapevolezza interna o dello sguardo degli altri…
Per certi versi credo si possa dire che nei miei libri cerco di indagare ciò che viene spesso presentata come «l’identità nera», anche se il mio punto di partenza è un quesito aperto rispetto a cosa si celi davvero dietro questo termine piuttosto che una risposta o un’affermazione certa. Quelle a cui fa riferimento sono le medesime domande che mi pongo da una vita e che attraversano tutto il mio lavoro.
Per tentare di risponderle, voglio però sottolineare come il mio punto di partenza sia l’aspetto psicologico dominante nei gruppi, nelle «comunità» e il modo in cui si percepiscono e vengono viste dagli altri. E ciò di cui sono sicuro è che anche quando questi gruppi possono essere identificati in base a delle peculiarità sociali o culturali, l’idea che queste caratteristiche siano date una volta per sempre è decisamente falsa. Tutto ciò che li identifica è al contrario mutevole, transitorio e in continua evoluzione. Pensare il contrario è spesso proprio un alibi per stabilire gerarchie di ogni sorta e perpetrare le discriminazioni.
Non temo Trump però sto all’erta
Parla lo scrittore che nel suo nuovo romanzoLo schiavista immagina il ritorno della segregazione razziale negli Usa Paradossalmente ripristinata da un afroamericano Elisabetta Pagani Busiarda 5 12 2016
Inutile chiedere a Paul Beatty cosa gli frulli per la testa sul suo prossimo romanzo. Ovviamente un’idea ce l’ha, ma non si sogna più di parlarne. «L’ho fatto una volta con un conoscente mentre scrivevo Lo schiavista. Ricordo ancora la sua espressione, a metà fra lo schifato e l’allucinato. Ci ho messo una vita a togliermi dalla mente quella faccia». Cosa gli avesse raccontato sulla trama l’ha rimosso, «so solo che ho usato la parola segregazione». Perché è di un ritorno della segregazione razziale, paradossalmente ripristinata da un cittadino afroamericano che finirà davanti alla Corte Suprema degli Usa con l’accusa di schiavismo, che parla il suo ultimo libro. Un romanzo tosto, stralunato, osannato dalla critica, che gli è valso - è la prima volta per un americano - il Man Booker Prize, il premio inglese che dal 2014 è aperto agli autori di tutte le nazionalità.
Lo schiavista (Fazi) viene tradotto in giro per il mondo nel momento in cui alla Casa Bianca stanno per avvicendarsi il primo presidente afroamericano e il suo successore, Donald Trump, portato in trionfo dal popolo bianco dopo una campagna elettorale muscolare su temi come l’immigrazione. Beatty, afroamericano nato a Los Angeles che da tempo vive a New York, non vuole però incasellare il romanzo nella letteratura di denuncia, ci racconta a Torino dov’è stato di passaggio.
«Volevo scrivere un libro difficile da ignorare», ha detto. Però ci hanno provato: nel Regno Unito ben 18 editori l’hanno rifiutato.
«Davvero ho detto così? È che ero nervoso, temevo che la storia non sarebbe stata capita. Poi il mio editore mi ha rassicurato: “Questo libro è maledettamente folle, lo adoro”. A Londra però è stato difficile pubblicarlo, ma sa, nel mondo non ci sono tante persone coraggiose».
Negli Usa com’è stato accolto?
«Ognuno, leggendolo, si sente a disagio per ragioni diverse. Se lo prendi seriamente è un libro difficile da digerire, ma credo sia giusto così. È quando mi sento a disagio che imparo, anche se devo ammettere che io mi sento sempre a disagio come persona».
Quanto c’è della sua vita nelloSchiavista?
«Lì dentro c’è la mia testa, non so se ci sia la mia vita».
La storia è ambientata nella cittadina-ghetto immaginaria di Dickens, in cui il protagonista coltiva angurie e marijuana.
«Mi sono ispirato a un angolo di Compton, nella contea di Los Angeles, popolato da mucche e gente a cavallo. È un posto strano, fuori del mondo. Mi è sembrata l’ambientazione perfetta per questo pazzo libro».
Un pazzo libro in cui a reintrodurre la schiavitù è un nero. L’integrazione è un tema ancora aperto in America. Lei si è mai sentito discriminato?
«No», ride sorpreso. «E se fosse non scriverei per superare un trauma. La mia scrittura non ha funzioni terapeutiche o educative, per carità».
Lei è nato nel ’62, l’anno dell’indipendenza di molti Paesi africani e asiatici e l’anno in cui il presidente Kennedy annunciò una legge contro la discriminazione abitativa dei neri. Cinquant’anni e passa dopo cos’è cambiato?
«È quello che mi chiedo. È solo cambiata la superficie o di più? Credo di più, ma non so cosa significhi. È come con la Barbie».
La Barbie?
«Esistono mille tipi di Barbie [nel romanzo inserisce anche il modello schiava, ndr]: grassa, bassa, lavoratrice. Ma se chiedi a qualcuno di immaginarla, visualizzerà quella magra. In questi decenni la bambola è cambiata, ma lo è davvero nelle nostre teste? Voglio dire, se anche facesse tutte le cose giuste, gliele riconosceremmo? È un’immagine che aiuta a capire come vediamo i progressi».
È nato in California, che per molti si identifica con il sogno. Da Hollywood alla Silicon Valley.
«Sono andato al college a Boston e quando mi chiedevano di dov’ero rimanevano sorpresi. Non credevano che ci fossero neri in California. La gente ha una certa idea della California, anche se sbagliata, riduttiva. È un posto di frontiera, che lavora sodo perché gli sia riconosciuto un ruolo culturale».
Confina con il Messico, che Trump prometteva di dividere dagli Usa con un muro. Una prospettiva che la spaventa?
«Diciamo che ho i sensi allertati, sa come quando il cane tira su le orecchie? Ecco così. Ma non sono spaventato. Lo sono invece, e molto, i ragazzi a cui insegno alla Columbia. L’elezione di Trump ha toccato profondamente le loro vite. Non lo hanno votato, al contrario dei loro genitori, e improvvisamente si sono resi conto dell’importanza di diritti che davano per acquisiti sulla sessualità, la parità di genere, l’immigrazione».
Come immagina l’America di Trump?
«Non sono un veggente: non so cosa succederà, e comunque probabilmente niente».
Lo scrittore dev’essere, come si diceva un tempo, impegnato?
«No, ma è giusto sapere perché non lo sei. Limitarsi a dire di no è da pigri».
Lei perché non lo è?
«Perché dà una prospettiva alla scrittura. E non mi interessa».
Da professore di scrittura (alla Columbia), pensa che la creatività si possa insegnare?
«Credo che uno sappia o non sappia scrivere. Detto questo, da insegnante aggiungo che i miglioramenti si vedono davvero. E, da studente, che ci sono lezioni che ti aiutano a rompere una barriera, a capire che puoi farcela. A volte abbiamo bisogno del permesso per autorizzarci a esplorare, e la scuola ci dà questo permesso».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI






















Nessun commento:
Posta un commento