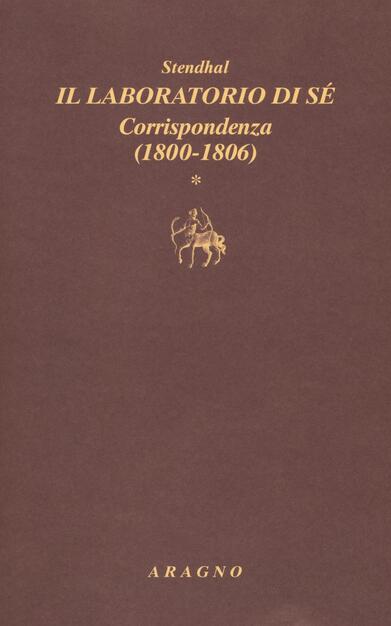 Stendhal: Il laboratorio di sé. Corrispondenza, A cura di Vito Sorbello, Aragno, Torino, Vol. IV (1822-1830), pagg. 557, Vol. V (1831-1832), pagg. 687, Vol. VI (1833-1834), pagg. 637, Vol. VII (1835-1837), pagg. 635,
Stendhal: Il laboratorio di sé. Corrispondenza, A cura di Vito Sorbello, Aragno, Torino, Vol. IV (1822-1830), pagg. 557, Vol. V (1831-1832), pagg. 687, Vol. VI (1833-1834), pagg. 637, Vol. VII (1835-1837), pagg. 635,lunedì 6 aprile 2020
Nuovi volumi delle corrispondenze di Stendhal
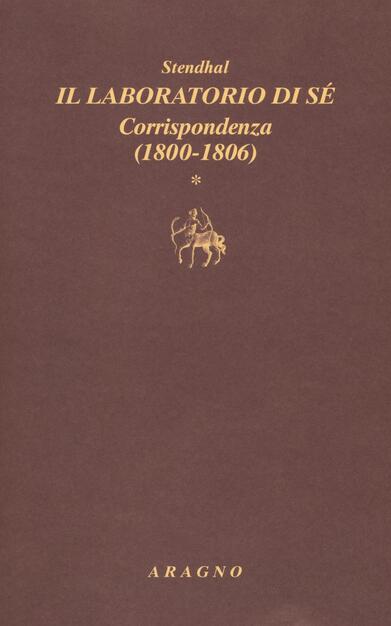 Stendhal: Il laboratorio di sé. Corrispondenza, A cura di Vito Sorbello, Aragno, Torino, Vol. IV (1822-1830), pagg. 557, Vol. V (1831-1832), pagg. 687, Vol. VI (1833-1834), pagg. 637, Vol. VII (1835-1837), pagg. 635,
Stendhal: Il laboratorio di sé. Corrispondenza, A cura di Vito Sorbello, Aragno, Torino, Vol. IV (1822-1830), pagg. 557, Vol. V (1831-1832), pagg. 687, Vol. VI (1833-1834), pagg. 637, Vol. VII (1835-1837), pagg. 635,
Vol. VIII (1838-1842), pagg. 569, € 35 ciascuno (I volumi I, II e III delle lettere sono stati pubblicati nel 2016 sempre da Aragno)
Stendhal turista a caccia di felicità
Corrispondenze. Le lettere dello scrittore sono un monumento di fatti e aneddoti sull’Italia: dalle considerazioni sul diffondersi del colera del 1831, al pedinamento della polizia di Firenze, fino ai soggiorni a Roma e Napoli
Scaraffia Domenicale 5 4 2020
«Mi
preme annunciarvi che l’autorità pontificia allarmata dal progredire
del colera ha sottoposto a una quarantena di quattordici giorni tutti i
bastimenti provenienti dai porti della Francia», scriveva Stendhal
nell’estate del 1831. Per poi concludere: «A Vienna il terrore è al
culmine». Malgrado il suo amore per l’Italia era dubbioso sull’efficacia
di un cordone sanitario affidato a soldati italiani. «I medici migliori
pensano che non ci siano cure; il malato ha cinque possibilità contro
una di andarsene ad patres. Ah! Se non ci fossero le atroci sofferenze, ho sempre desiderato una morte veloce».
Per
il momento però si limitava a morire di noia in un «un buco
abominevole», Civitavecchia, dove era stato nominato console, ma si
annoiava tremendamente. La sua carica lo metteva a contatto con un mondo
marinaresco e commerciale che non gli interessava. Come se non
bastasse, aveva accanto a sé un infido cancelliere, Lysimaque Tavernier,
che, mentre lo chiamava «padre mio», faceva la spia sulle sue numerose
assenze e gli faceva ogni tipo di dispetti. Quella carica, inutile
negarlo, era una resa. «Ero convinto di potere vivere della bellezza
come unico cibo, ma è impossibile». La sua massima per resistere alle
infinite punture di spillo e ai labirinti della burocrazia era
«fregarsene decisamente di tutto», sintetizzata in S.F.C.D.T. («Se foutre carrément de tout»).
Ma
neanche la sua salute era ottima. Le malattie immaginarie si
mescolavano a quelle reali, il timore di prendersi il colera gotta,
curato con l’oppio. Costretto a usare gli occhiali, sentiva con ansia
avvicinarsi i cinquant’anni. Non bastava a rassicurarlo la sua relazione
con una giovane e avvenente nobildonna, Giulia Rinieri de’ Rocchi, che
l’aveva stupito due volte. La prima baciandolo di sua iniziativa - «So
bene e da molto tempo che sei vecchio e brutto» - e la seconda
rifiutando cortesemente la sua proposta di matrimonio. Doveva
ammetterlo, in campo amoroso «le mie vittorie non mi hanno dato un
piacere comparabile alla metà della profonda infelicità causata dalle
mie sconfitte».
I pettegolezzi che arrivavano per lettera dalla
Francia lo ristoravano per un momento, ma poi si ritrovava solo in
quella misera cittadina. Meglio allora rifugiarsi nell’oasi solitaria
della memoria. «Mi diverto a scrivere i bei momenti della mia vita; in
seguito farò probabilmente come con un piatto di ciliegie, scriverò i
momenti brutti, i torti che ho avuto, e la disgrazia che ho avuto di
dispiacere sempre alle persone a cui volevo piacere».
In realtà
due terzi del suo tempo andava ai viaggi nel «paese della caccia alla
felicità» e ai soggiorni romani, amareggiati però dalla diffusa
ipocrisia. «Quando si arriva a Roma da Napoli, si ha l’impressione di
entrare in una tomba. Sono rari i contrasti così dolorosi. Si passa
dalla città più allegra a quella più triste del mondo». Abituato a
esprimersi liberamente nei salotti di Parigi, turbava con la sua audacia
i romani che, nel timore di compromettersi, si allontanavano da quel
parlatore pericoloso. Nei salotti una congiura del silenzio sembrava
gravare sul suo ultimo libro, Il rosso e il nero, ritenuto immorale. Nessuno era al corrente del frammento Il lago di Ginevra,
scritto poco dopo l’uscita del romanzo, poche pagine di un lirismo
sommesso, in cui un diciottenne è estasiato dalla «sublime bellezza» del
lago di Ginevra. Un incanto che neanche la grettezza del suo compagno
di viaggio riesce a incrinare.
Secondo i benpensanti era lui il
proprio peggiore nemico con il suo vizio di scherzare su tutto, di
rovesciare le opinioni comuni e deridere l’autorità. Persino nella
taverna Lepri di via Condotti quell’uomo dal fisico appesantito sotto il
frac all’ultima moda scandalizzava gli artisti, demolendo le glorie
consacrate, davanti a una stracciatella e a un bicchiere di Orvieto.
Solo un piccolo gruppo beveva, affascinato, ogni parola della
scintillante conversazione «piena di audacia, di fuoco e di brio». Tra
loro però c’erano anche le spie della polizia che guardava con sospetto
quel console cui Metternich aveva rifiutato l’autorizzazione per la sede
di Trieste.
Nella sua vita, Stendhal aveva assistito a
un’accelerazione inedita della storia. La monarchia era affondata,
lasciando posto alla rivoluzione, rimpiazzata due volte da Napoleone e
dai Borboni per poi approdare a Luigi Filippo. La rapidità degli
avvicendamenti aveva reso più sgraziati i tradimenti di chi di volta in
volta abbandonava gli sconfitti per i vincenti. In quella società
ambigua, che cercava di mascherare con l’ipocrisia e la retorica il
proprio opportunismo, Stendhal era un perfetto estraneo e non perdeva
occasione per predire l’imminenza di una rivoluzione destinata a
spazzare via il mediocre regno di Luigi Filippo, cui doveva peraltro la
sua carica.
In questa scintillante, magnifica corrispondenza, un
vero monumento letterario, intessuta di pensieri e di aneddoti e
ottimamente curata da Vito Sorbello, si annidano perle come il resoconto
di un pedinamento della polizia a Firenze. Vediamo così in un verbale
lo scrittore uscire dalla locanda alle 9,30, sostare due ore al
Gabinetto Vieusseux, un’ora agli Uffizi, comprare qualche libro francese
e tornare al Vieusseux. Per poi passare ai bagni di via delle Terme,
tornare di nuovo al Gabinetto e cenare in una trattoria con un giovane
sconosciuto alla spia. Dopo il pasto si era seduto a un caffè di piazza
del Duomo per poi ritirarsi nella sua locanda. Un’ultima sosta al
Viesseux e poi era andato a dormire. «Avendo il sorvegliante fatto
balenare il sospetto che potesse accorgersi di essere oculato, fu
creduto conveniente di sospendersi per ora la vigilanza». La polizia non
poteva sapere che in realtà Stendhal andava a Firenze nella speranza di
vedere Giulia Rinieri.
Stava cominciando quelli che sarebbero diventati i Ricordi di egotismo, mai finiti come non riusciva a finire Una posizione sociale o l’incantevole Paul Sergar,
anch’esso rimasto allo stato di frammento, in cui il passato si
ripresenta sotto mentite spoglie. Il padre di Paul non somiglia infatti a
quello maldestro del narratore ma all’amatissimo nonno. È rimasta la
matrigna «bella e cattiva» che calunnia Paul e trasforma la sua infanzia
in un periodo tristissimo. Lui «aveva un carattere appassionato e
ombroso: la sua immaginazione ne fece una tragedia e aumentò molto la
sua infelicità», spingendo a pensare al suicidio.
Ben lontano
dall’egoismo, l’egotismo di Stendhal era lo scudo trasparente che
opponeva alle insidie del tempo e alle tentazioni dell’ambizione. Era la
consapevolezza della superiorità delle gioie dell’arte, dell’amore e
della bellezza ai miraggi della carriera e degli onori. Non aveva niente
a che fare la pomposa celebrazione di sé di quel «puzzone» di
Chateaubriand, «il re degli egotisti».
Continuava a prendersela
con Dio che non esisteva o era cattivo. «La vita di per sé non è né bene
né male. È il luogo del bene e del male a seconda che li vogliate. È un
canovaccio da ricamare con seta rossa o lana nera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


















Nessun commento:
Posta un commento