Dietro al dialogo si intravede un cospicuo investimento di talento: investimento nella ricerca linguistica, investimento nella costruzione di effetti comici o drammatici, investimento nella raccolta delle fonti di informazione, investimento nella inventio. Varrebbe la pena di analizzare il dialogo dal punto di vista degli imprestiti dal lessico della commedia (Plauto, Terenzio) e di riflettere sull'uso sapiente di interiezioni, formule deprecatorie, avverbi variamente combinati fra loro, il tutto al fine di modulare il tono della voce degli interlocutori (dal furore all'ammiccamento, dalla minaccia all'ironia, dalla risata alla parenesi). Questo investimento di talento letterario renderebbe una traduzione scolastica, di quelle che piacciono ai nostri pedanti, un sostanziale tradimento dell'originale. La mia traduzione vuol essere un'interpretazione fedele, ma non è sempre una traduzione letterale. Riportare in luce qualche debole scintilla di quello che fu lo sfolgorio originale dell'operetta è stato il mio obiettivo primario.
di Luciano Canfora Corriere 13.4.14
Anna Peeters, protagonista del romanzo di Simenon Chez les Flamands (1932: La casa dei Fiamminghi ), convoca nel suo paesino sul confine del Belgio, Givet, da Parigi, il commissario Maigret perché indaghi sulla uccisione di Germaine Piedboeuf. Anna è in realtà colei che ha ucciso la ragazza: per stornare i sospetti che nel paese si indirizzano verso i Peeters, ricchi e poco amati fiamminghi, Anna promuove essa stessa la caccia all’assassino. Maigret lo capirà dopo un bel po’, ma, non essendo in missione ufficiale, non denuncerà la donna. Ripartirà per Parigi di umore nero.
Un grande fiammingo, Erasmo da Rotterdam, adottò, in una situazione delicata, la stessa tattica di Anna Peeters. Autore — come Silvana Seidel Menchi ha definitivamente dimostrato — della feroce satira postuma contro il terribile Pontefice Giulio II (Giulio , Einaudi, pp. CXLIV+168, e 28), Erasmo, non appena il libello cominciò a circolare suscitando clamore, fu lui stesso ad ostentare zelo nel dare la caccia all’autore. «Molto presto — scrive la dotta curatrice — fu lui a guidare la caccia». «Illustrò la difficoltà del problema. Avanzò congetture riguardo al luogo di nascita dell’opuscolo: la terra d’origine, suggerì, doveva essere la Francia, dove queste quisquilie circolavano con sfrenata licenza, oppure la Spagna. Sulla identità dell’autore avallò molteplici e contraddittorie congetture».
Il libello era suo. E l’autrice di questa eccellente edizione dimostra in modo ferreo che a lungo era sopravvissuto e aveva circolato l’autografo, indubitabilmente di pugno di Erasmo. Il che rende comico il perbenismo dei molti studiosi, anche grandi, che si sono affannati, nei secoli, a negare la paternità erasmiana del libello.
Qual è il contenuto di questa satira in elegante latino e in forma di dialogo? Il Papa, appena passato nel mondo dei più, si reca in Paradiso con un imponente seguito di armigeri e accompagnato però anche da un sardonico «Genius» — il suo Genio! — che gli fa il controcanto. Le chiavi di San Pietro, che ha con sé, non gli funzionano: La porta del Paradiso è sbarrata e San Pietro, guardiano guardingo, si guarda bene dal farlo entrare. Tra i due si intreccia un dialogo via via più aspro. Pietro interpreta P.M. (Pontifex Maximus ) come Pestis Maxima . Le allusioni ai molti vizi del Pontefice abbondano, ma soprattutto il nucleo dello scontro sta nel fatto che tutto ciò che Giulio II adduce come argomenti a proprio favore, che dovrebbero legittimare il suo ingresso trionfale in Paradiso (potenza mondana, violenza, guerre, ambizione sfrenata), appare a Pietro come fondamento certo per escludere Giulio II dal cielo. In tal modo viene ripercorsa l’intera parabola di quel pontificato simoniaco e ultrapolitico. Quello che al Papa appare come trionfo della Chiesa è invece per Pietro l’infamia in cui la Chiesa è stata da lui ridotta. Al termine — ed è conclusione lievemente ambigua — Pietro suggerisce a Giulio di andare altrove a edificare un paradiso tutto suo, nel quale avrà stanza anche il suo esercito: «Costruisciti un nuovo paradiso, ma ben fortificato, che non possa essere espugnato dai diavoli». E Giulio si allontana minacciando: tornerà con un esercito ancora più grande, composto dai moltissimi morti delle guerre che sulla terra continuano incessanti. (Macabra ironia che fa pensare alla carducciana Sacra di Enrico Quinto ).
Lo spunto per l’invenzione della trama — un sovrano, il Pontefice, scacciato dal cielo, dove sembrava ovvio dovesse approdare — venne ovviamente a Erasmo dalla grande novità del momento: la appena edita (agosto 1513) Apocolocintosi di Seneca. Giulio II era morto nel febbraio, ed Erasmo, come la Seidel Menchi ha dimostrato, si mette a scrivere nel maggio 1514. Del resto Erasmo si era già ispirato esplicitamente alla Apocolocintosi anche nell’Adagio 201 («Re o stolti si nasce »). In quel libello fulminante, Seneca immaginava che l’imperatore Claudio, appena morto, e perciò fatto dio secondo una prassi instaurata da Augusto, salisse al cielo ma, a seguito di un acceso dibattito, nel concilio degli dei, ne venisse scacciato soprattutto per l’efficace, vibrante invettiva di Augusto contro di lui. Nel corso della quale, il fondatore del principato, tracciava un profilo feroce del governo di Claudio e delle sua tare. Lo stesso accade nel Giulio , nel corso del dialogo tra Giulio II e San Pietro.
Erasmo aveva avuto tra mano l’editio princeps della satira di Seneca e l’aveva riedita nel 1515 stampandola insieme all’Elogio della follia , nel cui capitolo 59 c’è già il nucleo della satira contro Giulio II. Sia consentito dire che Seneca fu più breve e più efficace.
Alle fonti ispiratrici di Erasmo io credo si debbano aggiungere anche i Cesari dell’imperatore Giuliano (volgarmente detto l’Apostata). Satira, anche questa, culminante nella finale cacciata dall’Olimpo di un altro sovrano: Costantino («detto dai preti il Grande» diceva Engels), inviso a Giuliano come a tutti i seguaci delle antiche fedi religiose e filosofiche. Costantino viene distrutto, nell’esame che vien fatto della sua criminosa carriera, e alla fine scacciato dall’Olimpo, accompagnato dalla Mollezza e dalla Débauche. Giuliano, sferzante, fa dire conclusivamente a Ermes che Gesù ha l’impudenza di cancellare i peccati: àncora di salvezza per un cattivo soggetto come Costantino.
Che Erasmo conoscesse questo testo, la cui edizione a stampa fu molto ritardata (1577), è probabile, se solo si considera che il Marciano greco 366 (manoscritto del «tesoro di Bessarione» = nr. 75 dell’inventario del 1474) può averlo visto a Venezia durante l’anno (1507-1508) in cui vi soggiornò in stretto contatto con Aldo Manuzio, curando la stampa degli Adagia . Non va dimenticato inoltre che il più importante codice giulianeo, il Vossiano greco F 77, aveva circolato tra Giovanni Crisolora e Gemisto Pletone, per giungere poi a Padova e infine, dopo molto, a Isaac Vossius.
La stampa senza nome d’autore, a cura di Hutten, luterano verace, del Giulio ebbe un successo enorme. Erasmo si spaventò e si consacrò a fabbricare le false piste di cui s’è detto in principio. Anche Hutten, del resto, pubblicò anonime le sue Lettere di uomini oscuri , ferocemente antipapali, rivolte soprattutto contro Leone X e la sua corte. La questione che si presenta è dunque quella della prudenza e della doppiezza: due doti tipiche degli umanisti, non solo di quei tempi. Si può dire che in Hutten si rileva la prudenza, in Erasmo la doppiezza.



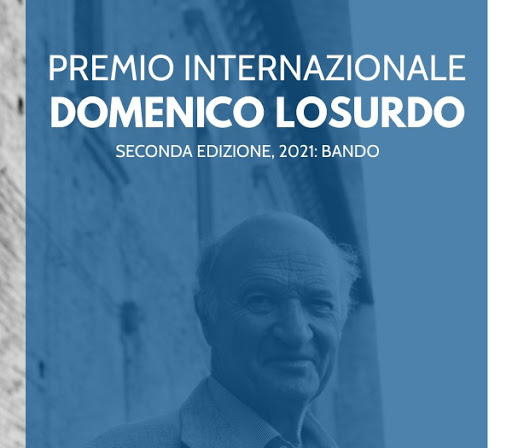


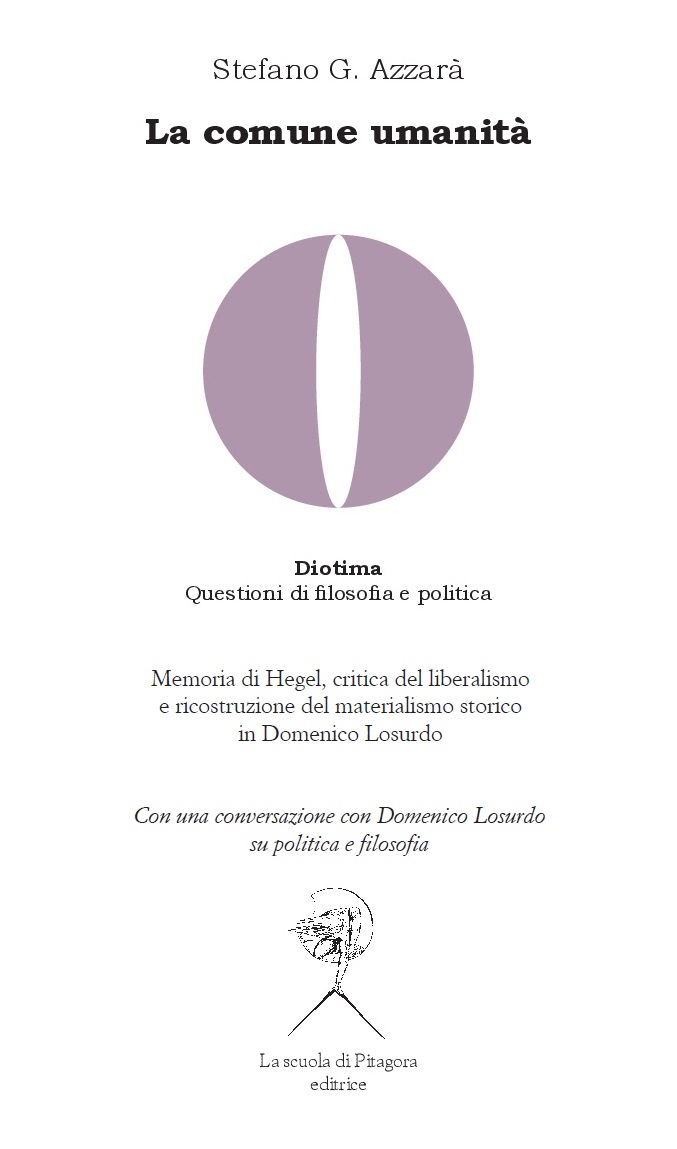




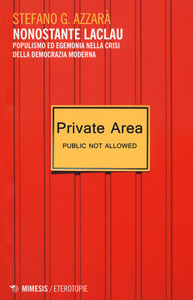


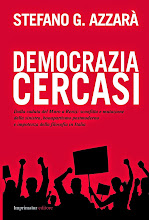
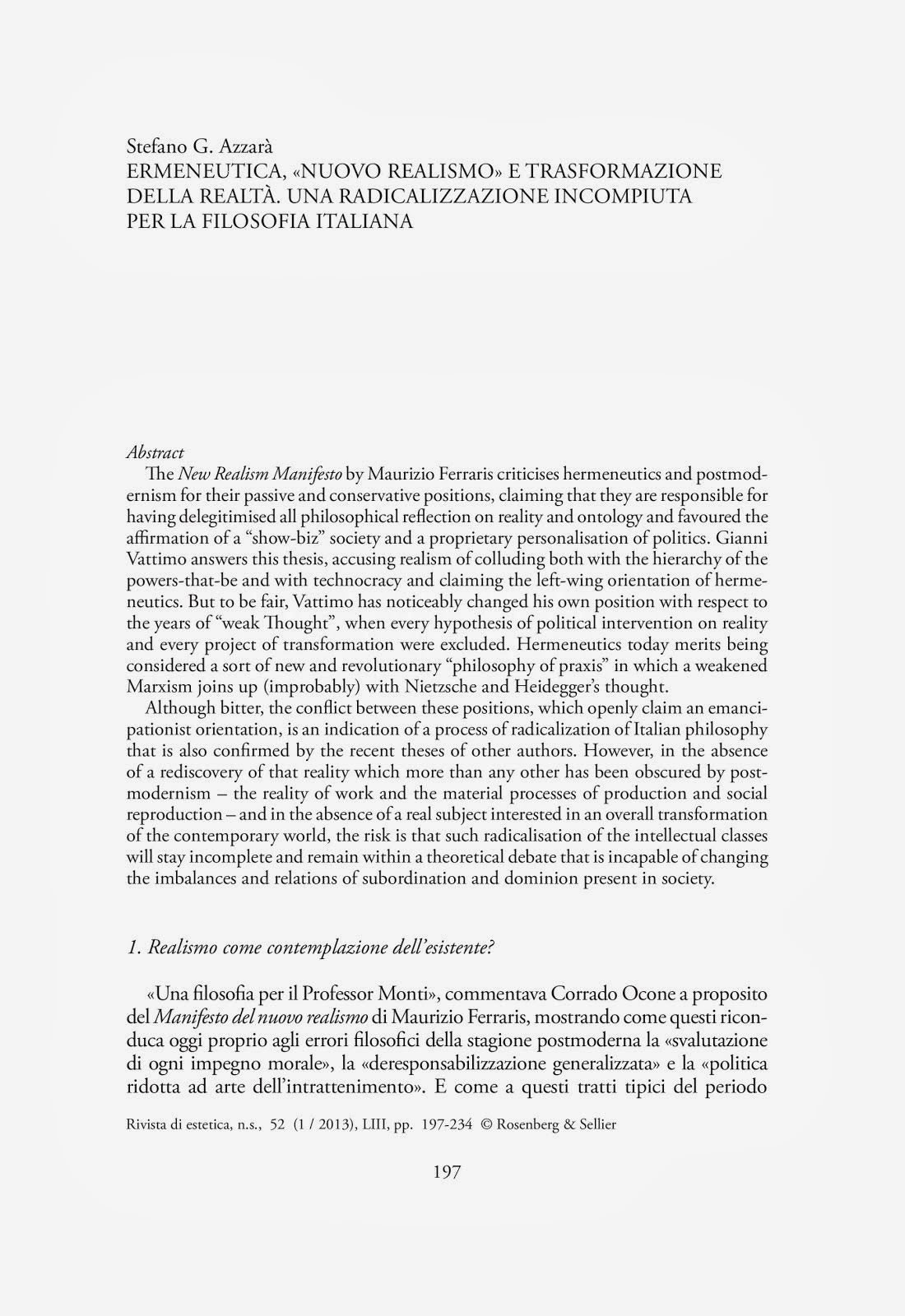


Nessun commento:
Posta un commento