L’antropologia romana ha bisogno del filologoMaurizio Bettini, «Dèi e uomini nella città», Carocci. Roma e gli dèi altrui, l’«autobiografia» bilingue di Augusto, il funerale aristocratico, il parto cesareo... Una raccolta di saggi chiari e pacati
di Carlo Franco il manifesto 15.11.15
L’antichità greca e romana occupa da lungo tempo uno spazio nell’identità dell’occidente. Se lo avrà ancora in futuro, è difficile dire: probabilmente sarà sempre più marginale. Ma intanto gli antichi continuano a sollecitare la nostra riflessione: certo, non più in termini di esemplarità o di valore assoluto, e sempre più raramente anche in termini di «attualità». Produttivo resta però il loro ruolo di paradigma culturale sul quale esercitare il nostro sguardo. Le ricerche che Maurizio Bettini conduce almeno a partire dall’ormai classico Antropologia e cultura romana (1986, trad. ingl. 1991) vanno precisamente in questa direzione: oggetto di analisi sono mentalità, credenze, identità della Roma antica, studiate non con la superiorità del moderno che a proposito degli antichi «la sa più lunga» di loro (il Besserwissen, così caratteristico degli antichisti, un tempo), ma con l’intento di comprendere la cultura romana secondo le categorie che le furono proprie. Giacché gli antichi, sebbene per alcuni aspetti siano vicini a noi, ci sono lontani per altri, e misconoscere questa «alterità» conduce a equivoci culturali e storici. Il percorso di Bettini prosegue ora con una nuova raccolta di saggi, che rielabora contributi precedenti apparsi anche in sedi estere (Dèi e uomini nella Città Antropologia, religione e cultura nella Roma antica (Carocci «Frecce», pp. 213, euro 19,00). E il primo aspetto da notare, proprio perché il libro lo sottintende, è che la cultura romana, pur se largamente influenzata da quella greca, ebbe caratteri suoi specifici: sicché chi studia le mentalità, i riti, i valori simbolici, le strutture profonde, è libero dal problema della «originalità» dei romani. Annosa questione, che ha condizionato (non sempre bene) l’approccio alla letteratura e delle espressioni artistiche in latino, e che ha avuto l’effetto di far trascurare quanto pur c’era di specificamente romano. Eppure, Plutarco doveva spiegare ai suoi lettori le «cause» di tante usanze che a un greco risultavano strane o incomprensibili (Questioni romane): segno che ancora nella civiltà bilingue dell’impero si percepivano differenze marcate tra le due culture. Oggi la ricerca incontra problemi differenti: ci si confronta con una cultura che non è vivente, ma solo con le sue testimonianze per lo più scritte, e questo richiede un’attenzione forte al metodo: «si può fare antropologia “etnica” romana solo a patto di fare contemporaneamente ermeneutica e filologia dei testi che possediamo» (p. 70). A differenza dalla via seguita da altri approcci al mondo antico, la lingua continua qui ad avere un ruolo importante: essa è uno degli strumenti principali utili a comprendere «i Romani secondo i Romani». Gli argomenti dei saggi, sviluppati con la chiarezza pacata che è caratteristica di Bettini, conducono il lettore in direzioni differenti, tra religiosità e pratiche culturali, unificate dal ricorso a strumenti antropologici e anche filologici. L’attenzione al latino non è concessione professorale, né compiacimento elitario, né feticismo per l’espressione originale: Bettini, che alla «antropologia della traduzione» ha dedicato un libro importante (Vertere, Einaudi 2012), è guida sicura all’operazione, rischiosa ma ineludibile, di interpretare gli antichi a partire dalle loro parole. Lo mostrano saggi come quello sulla interpretatio Romana, che dissipa un equivoco assai comune sul modo in cui a Roma si approcciavano gli dèi «degli altri», o quello sul concetto di auctoritas, così rilevante anche sul piano politico. Nel primo caso si dimostra come l’incontro con le divinità delle altre culture procedesse secondo i caratteri «indiziari» dell’analogia e della congettura; nel secondo si chiarisce che la auctoritas implica una «forza» che emana dall’interno del soggetto, e non deriva dall’esterno. La portata politica di questa lettura appare quando la si applica a un testo «politico» se mai altri ve ne sono, come le Res gestae di Augusto, la grande «autobiografia» destinata a perpetuare l’immagine trionfale del triumviro fattosi padre della patria. Del testo si conserva, nella monumentale iscrizione di Ankara, la versione latina e quella greca, e da tempo gli storici hanno rilevato, fin dalle prime righe, le sottili differenze tra i due testi, che parlano a pubblici differenti dicendo cose differenti. Ebbene, nel passo in cui Augusto chiarisce di essere stato pari in potestas, ma superiore in auctoritas a tutti coloro che ebbe colleghi nelle varie magistrature, auctoritas è reso in greco con exousía, che rinvia invece a un fondamento esterno della «autorevolezza», ben lontano dal concetto latino. Questo esempio mostra chiaramente che non ha spazio qui l’antistoricità, l’amore per schemi astratti dalle contingenze sociali e politiche, spesso rinfacciata agli studi antropologici del mondo antico: anche gli appassionati della politica troveranno in questo libro ampio materiale di riflessione circa episodi famosi e significativi. I funerali importanti, ad esempio. Quello di Giunia, moglie di Cassio e sorellastra di Bruto, morta nel 22 AD, è rimasto celebre perché Tacito ricorda (Annali, 3.76.2) che nell’occasione le imagines dei due cesaricidi non poterono sfilare nel corteo, ma che tutti ne notarono l’assenza: ebbene, accanto alla valenza politica, l’episodio riguarda il modo in cui la cultura romana strutturava i funerali aristocratici, secondo una griglia di valori complessa e unicamente romana. E lo stesso vale per il «mimo» che prese parte al funerale di Vespasiano (Svetonio, Vespasiano, 19), o per la caricatura scritta da Seneca alla morte del poco amato Claudio: entrambi i casi richiamano (anche) la compresenza di lutto e scherno che caratterizzava le cerimonie funebri romane. E Bettini fa notare che quando questi e altri testi sono usati come «documenti», senza valutare in essi l’incidenza dei modelli culturali, si è incorsi in gravi fraintendimenti. L’approccio antropologico chiama dunque in causa anche le grandi questioni: la riflessione sul modo in cui romani pensavano il proprio inizio come popolo, in assenza di una rappresentazione cosmogonica, conduce a ragionare sulla «ideologia» dell’inizio di Roma (e non sulla presunta storicità di Romolo e dei suoi muri…). E dal mito di fondazione esce un quadro di «apertura» e mescolamento (p. 23) che deve forse qualcosa a suggestioni contemporanee, ma che rinvia a una questione strutturale del massimo interesse (importante il saggio di Philippe Gauthier, “Générosité” romaine et “avarice” grecque: sur l’octroi du droit de cité, del 1974). Pure, fra problemi complessi e strumenti dotti, a questo libro di Bettini va ancora una volta riconosciuta la qualità della leggerezza, conseguita con un racconto disteso e con l’apertura a situazioni (fatti, aneddoti) «sorprendenti» ma capaci di suggestioni non superficiali. Avviene così nell’ultimo capitolo, dedicato al parto cesareo, ossia alla nascita non naturale, che parte della tradizione antica attribuì (erroneamente) a Cesare: un percorso che conduce attraverso nascite miracolose e ominose di uomini grandi, e che porta finalmente a capire perché Macduff sconfigge Macbeth, protetto dalla profezia delle streghe («te non ucciderà nato di donna»). Giacché, come lo stesso Macduff rivela allo sgomento re, «Nato non sono: strappato fui dal sen materno» (IV.9, nella versione di F.M. Piave per Verdi). Perché i modelli culturali romani hanno, appunto, una lunga storia.
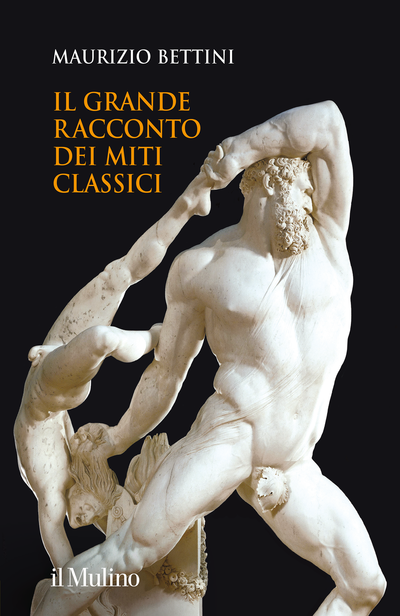
Maurizio Bettini:
Il grande racconto dei miti classici, Il Mulino, Bologna, pagg. 504, € 48,00
Risvolto
Per i Greci i miti sono in primo luogo racconti: narrazioni meravigliose, che mescolano il divino e l'umano, il quotidiano e lo straordinario, suscitando davanti ai nostri occhi immagini di eroi, dèi, fanciulle, mostri e personaggi fiabeschi. Una schiera interminabile, perché più ci si addentra in questo fantastico mondo - attraverso l'ausilio della voce, della scrittura o delle immagini - più ci si accorge che ciascuno di questi racconti non è mai concluso in sé, ma rinvia sempre ad altri eventi, altri personaggi, altri luoghi, in un raccontare infinito che chiede solo di diventare a sua volta immagine o scrittura. La mitologia ha infatti la forma di una rete, in cui si intrecciano mille nodi. Nel corso del tempo, questa rete con i suoi molteplici richiami narrativi è stata calata infinite volte nel mare della cultura e, trascinata sul fondo, ha raccolto nomi, fatti, rituali, usi, costumi, regole, atteggiamenti, visioni del mondo. Per questo raccontare o ri-raccontare oggi i miti degli antichi significa entrare dalla porta principale nella memoria della loro, della nostra cultura.
Miti riscritti alla Borges
Maurizio Bettini racconta la cultura greca affontando problemi curiosi. Per esempio, cosa cantavano le sirene?
Piero Boitani Domenicale 15 11 2015
«Il mito», scrive uno dei maggiori poeti europei del Novecento, il portoghese Fernando Pessoa, «è il nulla che è tutto». L’affermazione suonerebbe come una generalizzazione senza senso se non fosse subito qualificata da due esempi importanti, uno di mitologia «teologica», l’altro di mitologia «eroico-storica». Il primo riguarda il sole, «mito brillante e muto» perché è «il corpo morto di Dio / vivente e nudo». L’astro rappresenta infatti da sempre la divinità: essa muore al tramonto e risorge all’alba. Il secondo esempio verte invece su Ulisse, il navigatore protagonista dell’Odissea, del canto XXVI dell’Inferno di Dante e di mille altre storie. Una leggenda diffusa nell’antichità e nel Medioevo e particolarmente rilevante per il Portogallo sostiene che, prima di scomparire nell’Atlantico, Ulisse abbia fondato Lisbona («Ulixabona»). Pessoa scrive: «Questi, che qui approdò, / fu per il non essere esistente. / Senza esistere ci bastò. / Per non essere venuto venne / e ci creò». Il discorso è paradossale e inclina alla metafisica, ma risulta chiaro nelle sue implicazioni: Ulisse è un personaggio mitico, dunque non è mai esistito nella realtà. È esistito, invece, come mito, sul piano del non essere. Tuttavia, il mito è sufficiente a dar forma al reale e soprattutto, nei miti di fondazione, a un’identità. Senza mai giungere in Portogallo, Ulisse ha “creato” i portoghesi, ha dato il suo volto a un popolo. «Così», conclude il poeta, «la leggenda si dipana / entrando nella realtà, / e a fecondarla decorre. / In basso la vita, metà / di nulla, muore».
Questo brano mi è tornato in mente leggendo il libro di Maurizio Bettini, Il grande racconto dei miti classici, nel quale l’autore narra tanti dei miti che il mondo greco ci ha lasciato, dall’inizio del cosmo a Teseo, da Medea a Pegaso, da Orfeo a Eracle, da Sisifo agli Argonauti. Trentotto capitoli, dove il filologo classico, che per Einaudi cura una serie intitolata Mithologica (nella quale hanno già trovato posto Sirene, Arianna, Circe, Edipo, Enea, Elena, Narciso), si lascia prendere dal gusto di narrare e incantare. Narra, come fa Ulisse ad Alcinoo delle proprie avventure nei Libri IX-XII dell’Odissea, «come un aedo», inanellando storia dopo storia, variante su variante, trama intrecciata con trama, quasi fosse un mitografo medievale, un ri-scrittore alla Borges. Racconta in maniera piana, comprensibile a tutti, tentando di restituirci quella che egli stesso chiama la «voce del mito»: una parola «che viaggia, che comunica dei racconti, degli intrecci, delle verità, e poi si perde nel vento» (mythos vuole dire racconto e parola allo stesso tempo). Racconta: talvolta si ferma a riflettere in guisa di antropologo o di storico della cultura, perché «il mito tramanda contemporaneamente una cultura, le sue regole e i suoi significati».
Insomma, si diverte e diverte. Per esempio, si domanda con l’imperatore Tiberio e con altri dopo di lui che cosa cantassero le Sirene (Omero non lo dice). Naturalmente, non può rispondere: allora, dopo aver descritto l’incanto che le Sirene dell’Odissea suscitano e la morte che esse nascondono (il brano è lì, sulla stessa pagina, a testimoniarlo), Bettini salta al viaggio degli Argonauti, durante il quale si svolge una gara di canto tra le Sirene stesse e Orfeo. Orfeo vince e le Sirene si gettano a capofitto dalla rupe. Le si ritrova però vivissime alla generazione successiva, perché uno degli Argonauti è Laerte, il padre di Ulisse, il quale dovrà a sua volta passare davanti alle Sirene e vorrà ascoltare il loro canto. Il mito opera corti circuiti del genere senza curarsi della cronologia o della geometria euclidea, e l’enigma del canto delle Sirene giunge intatto sino a noi. Qualcuno ha provato a rispondere alla domanda di Tiberio: Cicerone sostenne che le Sirene offrissero a Ulisse la conoscenza; Benjamin – glossando Il silenzio delle Sirene di Kafka – optava per la poesia, che resta muta dinanzi alla tecnica; Italo Calvino decide: le Sirene cantano «ancora l’Odissea, forse uguale a quella che stiamo leggendo, forse diversissima».
Il fascino di un libro architettato così, che si presenta a metà tra le Metamorfosi di Ovidio e le Genealogie degli dei pagani del Boccaccio, sarebbe quindi grande di per sé. Ma il volume possiede anche un’altra caratteristica che lo rende speciale: è abbondantemente, elegantemente, accuratamente illustrato, tanto da trasformarsi in libro dai mille colori e dai mille stili che parla anche agli occhi con forza travolgente. Il mito ha infatti esercitato sull’immaginazione degli artisti occidentali un’attrazione del tutto particolare, e ogni vaso arcaico, ogni scultura ellenistica o romana – migliaia di opere d’arte o umili oggetti quotidiani che sopravvivono a testimoniare, spesso in frammenti o rovine, l’età antica, si riverberano nelle miniature e nei capitelli medievali, negli affreschi del Rinascimento, nei quadri e nelle statue del Barocco, del Neoclassicismo, del Romanticismo, dell’Ottocento, giù giù sino ai film e ai fumetti del Novecento e del nostro postmodernismo. C’è un’Afrodite che nasce dalle acque sul cosiddetto Trono Ludovisi, del V secolo avanti Cristo, ma c’è anche una Venere sorgente dal mare, entro una conchiglia, da Pompei. Botticelli, Tiziano, Ingres, Picasso, Vania Elettra Tam: e poi Verushka in posa di Anadiomene nel 1968, e Kylie Minogue su conchiglia dorata durante l’Aphrodite Tour del 2010. Persino Chaucer, in pieno secolo XIV, presenta nella Casa della Fama Venere nuda sul grande mare. Se si sfogliano le centinaia di pagine che Joseph Reed ha compilato nel 1999 per la Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s (e che elencano anche opere musicali) ci si fa un’idea di tale universo.
Vederlo raccontato e illustrato in un volume fa bene all’anima. Uno studioso del IV secolo della nostra era, Saturnino Secondo Salustio, sodale e collaboratore di quell’imperatore romano che i cristiani chiamarono l’Apostata, offre questa definizione: «Anche il mondo infatti può esser detto un mito, poiché in esso corpi e oggetti si manifestano, mentre le anime e le intelligenze si nascondono». Il mito imita l’attualità degli dèi, il mondo è la realtà degli dèi in atto, «allusione a quelle essenze»: perciò mito. Davvero il mito è il nulla che è tutto.
Il racconto dei racconti custodito nei grandi miti Maurizio Bettini scrive un’opera per ritrovare le nostre radici Un modo per riscoprire le narrazioni classiche, a cominciare dalla sfida di PrometeoTOMASO MONTANARI Repubblica 20 12 2015
Ecco un libro che può abbattere il divario estremo tra le generazioni, anzi gettare un ponte per metterle in comunicazione: Il grande racconto dei miti classici, scritto magnificamente da Maurizio Bettini e illustrato sontuosamente dal Mulino. Bettini fa ciò che i nostri studiosi (sia umanisti che scienziati) non fanno quasi mai: riesce a parlare a tutti, a rendere letteralmente popolare il suo argomento di ricerca. Lo fa senza paternalismi, e senza scorciatoie o ammiccamenti attualizzanti: con un garbo da narratore intorno al focolare che riesce a restituire la sostanza e la forma del discorso del mito. Una forma che non conosce ortodossie, forme esclusive, verità assolute: ma che esiste solo nel momento in cui una voce canta per una comunità, tessendo il filo che lega insieme l’immaginario e l’orizzonte morale delle generazioni che si avvicendano intorno a quel fuoco.
Conoscere il repertorio di destini, situazioni, condotte morali contenute nel mito serve a costruire un’identità comune. Non intesa come una radice che ci avvinca ad un passato paralizzante, ma come la corrente di un fiume che accoglie acque diverse, pur correndo in un’unica direzione (e la metafora è di un altro bellissimo libro di Bettini: Contro le radici). Penso ai bambini che frequentano una classe in cui più di metà dei compagni vengono da paesi remoti: con altri miti e altri linguaggi. Per loro crescere condividendo la consapevolezza che è meglio essere come Prometeo che come suo fratello Epimeteo, o sapere quale differenza corra tra l’allocco Ascalafo e la civetta di Atena significa costruire un alfabeto condiviso: non un passato, ma un futuro comune. Questa fiducia in ciò che Salvatore Settis ha chiamato “futuro del classico” appare un antidoto vitale alla trasformazione del passato nel fantasy complottistico che ci viene propinato dalla tv, ma anche da molti libri scadentissimi, quanto fortunati. Questi si limitano a proiettare sul passato l’ombra deformante del presente: lasciandoci con le nostre solitudini e fissazioni, appena travestite in costume (pseudo) storico.
Il grande racconto dei miti classici fa tutto il contrario. Scrive Bettini: «La mitologia dei Greci è un’opera collettiva e individuale nello stesso tempo, in essa la tradizione e l’innovazione si susseguono senza posa, come le onde del mare». Tenere insieme tradizione e innovazione, il pensiero individuale e la partecipazione a un cultura diffusa: è un po’ come salvare una scintilla, e nasconderla nel gambo di una finocchiella selvatica. Perché il fuoco, prima o poi, torni a divampare. Ce l’ha insegnato Prometeo, no?


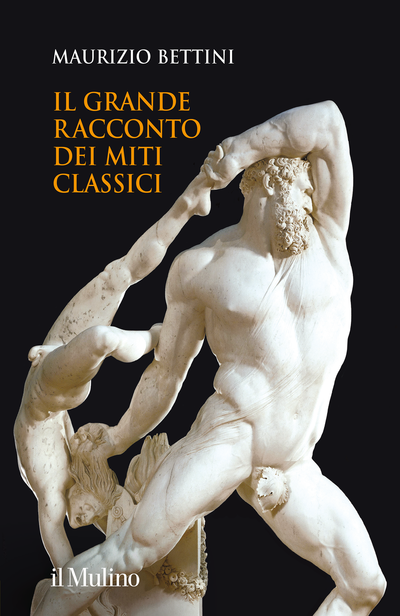


























Nessun commento:
Posta un commento