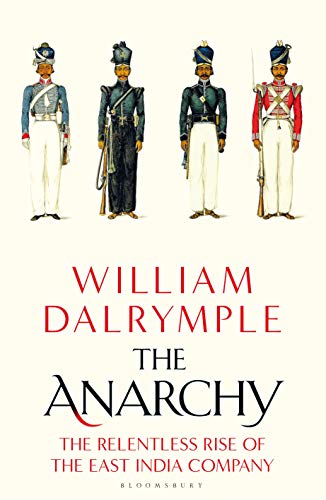 William Dalrymple: The Anarchy. The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, pagg. 544, € 33
William Dalrymple: The Anarchy. The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, pagg. 544, € 33lunedì 16 marzo 2020
Compagnia delle Indie e Impero britannico: Dalrymple
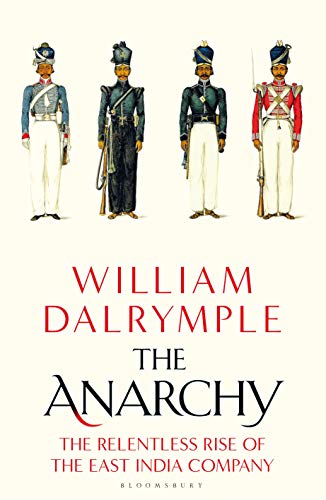 William Dalrymple: The Anarchy. The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, pagg. 544, € 33
William Dalrymple: The Anarchy. The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, pagg. 544, € 33
Compagnia delle Indie, tra fatti e misfatti
Ugo Tramballi Domeniale 15 3 2020
Nel
1614 la potenza di Jahangir rivaleggiava con i Ming cinesi, quando alla
sua corte si presentò Sir Thomas Roe, in nome di un’impresa fondata
quindici anni prima a Londra mentre William Shakespeare scriveva l’Amleto.
Dall’Afghanistan all’attuale Bangladesh, l’imperatore Mogul governava
su 100 milioni di sudditi e produceva un quarto della manifattura
mondiale. La popolazione inglese era il 5% della sua.
L’azienda di
Sir Roe, chiamata Compagnia delle Indie Orientali, possedeva un ufficio
con cinque finestre nel centro di Londra e i suoi 218 soci faticavano
ad armare una nave che tornasse dall’Asia con «fine cotone, indaco e
chintz». Pochi anni dopo la Compagnia avrebbe garantito dividendi del
3.600 per cento; un secolo dopo avrebbe preso l’intero subcontinente
indiano con un esercito di 200mila uomini in gran parte sepoy,
mercenari locali. Nel 1786 il filosofo e statista Edmund Burke avrebbe
definito la Compagnia «uno stato a guisa di mercante». Fu il suo tè
esportato dal Bengala e buttato dai ribelli nelle acque del porto di
Boston, a innescare la Rivoluzione americana. Come scrisse John
Dickinson, uno dei fondatori degli Stati Uniti, la Compagnia «voleva
mettere gli occhi sull’America come nuovo teatro, dove esercitare il suo
talento per il saccheggio, l’oppressione e la brutalità». Prima di
diventare duca di Wellington e battere Napoleone a Waterloo nel 1815, il
giovane Arthur Wellesley aveva guidato l’esercito della Compagnia e
conquistato «più territori in India, e più rapidamente, di quanto
Napoleone stesse facendo in Europa».
«Il loro business assomiglia
più a una rapina che a un commercio»; hanno «assassinato, deposto,
saccheggiato, usurpato», secondo Horace Walpole, contemporaneo di
Bur-ke. Ma la Compagnia fu il motore dell’imperialismo britannico.
«Isolati dai vicini campi di battaglia» dell’Europa cattolica, «gli
inglesi furono costretti a setacciare il globo per trovare opportunità
commerciali. Lo fecero con entusiasmo piratesco», scrive William
Dalrymple in The Anarchy. La sua storia della East India Company
non è solo il racconto di una vicenda drammatica e ripugnante. È anche
un grande affresco della potenza britannica spinta dalla sua avidità e
parzialmente redenta dalla sua democrazia; della lenta caduta della
magnificenza Mogul; della coraggiosa resistenza del raja di
Mysore a Sud e della confederazione Maratha a Ovest; di un saccheggio
senza limiti. Robert Clive, diventato “Clive of India”, fu il primo
governatore a conquistare territori, uccidendone i nawab, i ricchi governanti. «Dobbiamo essere noi stessi nawab, nei fatti se non nel nome: arretrare è ormai impossibile», decise in un incontrollabile delirio di onnipotenza.
Una
quarantina d’anni più tardi, quando anche il resto dell’India finì
sotto il controllo rapace della Compagnia, Thomas Munro, un altro
governatore, annunciò che «ora siamo i pieni padroni dell’India e niente
può scuotere il nostro potere». La Compagnia sopravvisse ai suoi
debiti, immensi quanto i guadagni, a scandali e processi, alle
interrogazioni parlamentari. Ma la Storia non conosce misure adeguate
che la congelino per troppo tempo.
Il 10 maggio 1857 l’esercito privato di sepoy
che aveva combattuto per trasformare la Compagnia in impero, «si
ribellò contro il suo datore di lavoro». Per gli inglesi fu l’ “Indian
Mutiny”, per gli indiani la Prima Guerra d’Indipendenza. La Compagnia
passò sotto il controllo della regina Vittoria nel 1859. Sopravvisse per
altri quindici anni. Chiuse per sempre nel 1874 «con meno fanfara della
bancarotta di una ferrovia regionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



























Nessun commento:
Posta un commento