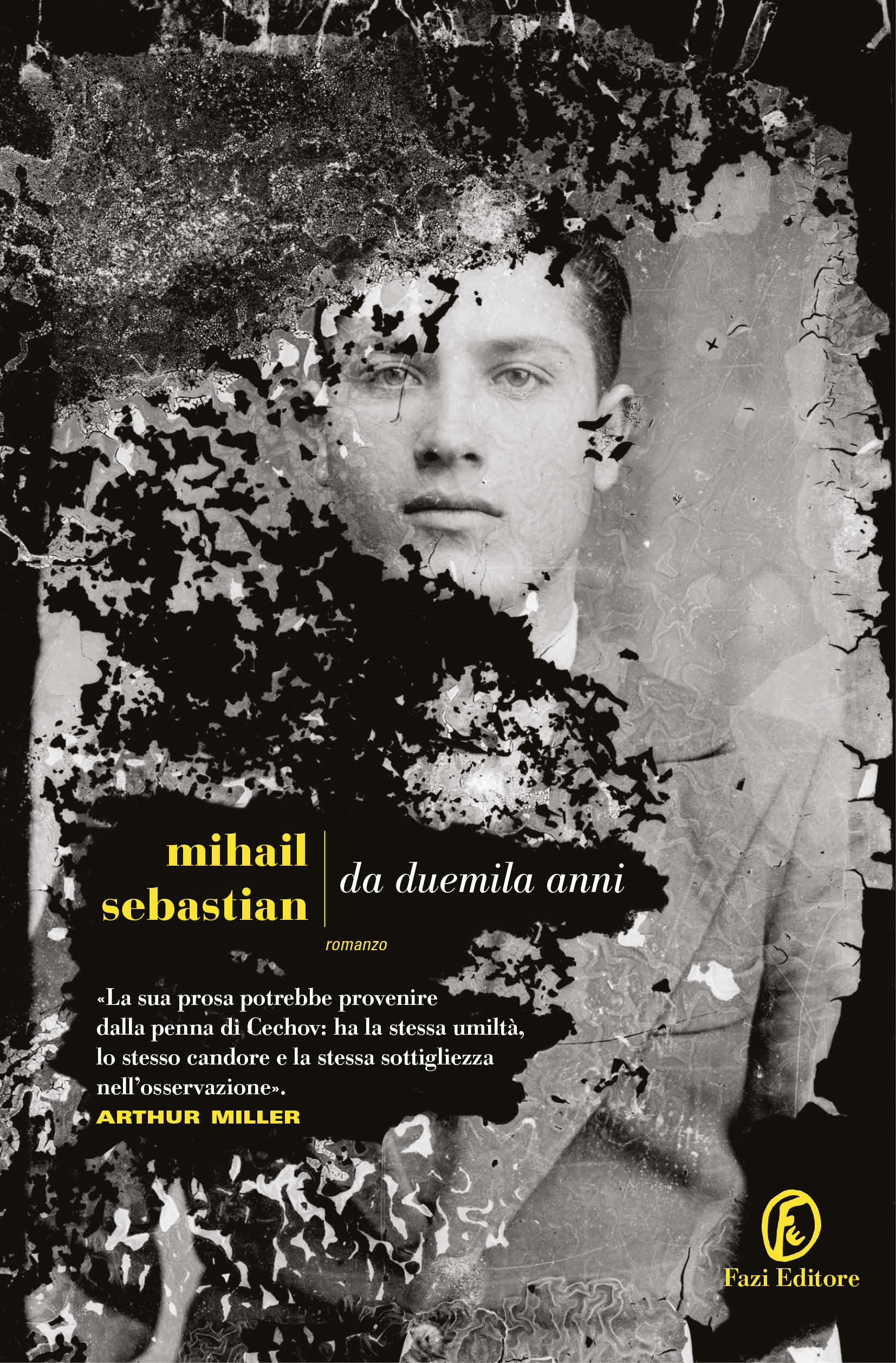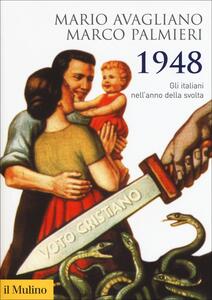
mercoledì 28 febbraio 2018
Il 1948, le elezioni e i primi passi della democrazia semicoloniale italiana: una storia
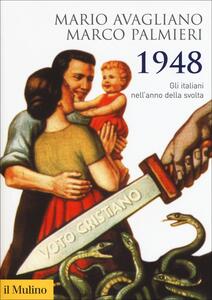
Mario Avagliano e Marco Palmieri: 1948. Gli italiani nell'anno della svolta, Il Mulino, pagg. 436, euro 25
Risvolto
Per l'Italia repubblicana le vicende del 1948 hanno sancito la fine
della travagliata transizione dal fascismo alla democrazia e l'inizio
di una fase politica nuova. Il voto del 18 aprile rappresentò anche una
netta scelta di campo nel bipolarismo della guerra fredda, scelta che
non fu messa in discussione neppure dalla grave crisi dell'attentato a
Togliatti, che in quello stesso anno portò il paese sull'orlo di
un'insurrezione e ai una nuova guerra civile. Come vissero gli italiani
quel passaggio tumultuoso? Quali ideali li animarono? Quali stati
d'animo, passioni e condizionamenti ne indirizzarono l'orientamento
politico? Diari, lettere, interviste, relazioni delle autorità e di
pubblica sicurezza, carte di partito, documenti internazionali,
giornali, volantini permettono di ricostruire il quadro complesso
dell'Italia dell'epoca, illuminando anche molte questioni che hanno
caratterizzato i decenni successivi, fino ai nostri giorni.
Cardini presenta Francesco d'Assisi come comunitarista reazionario e antimoderno
 San Francesco d'Assisi, un ribelle contro la modernità
San Francesco d'Assisi, un ribelle contro la modernitàNella nuova biografia scritta da padre Enzo Fortunato il fascino senza tempo di un ribelle: non contro la Chiesa ma contro la sua epoca che andava verso l’individualismoAvvenire Franco Cardini domenica 25 febbraio 2018
Lo scandalo della Banca Romana nella letteratura. Il parere del Nostro Toynbee come storico del Risorgimento e dell'unità nazionale
Romanzi parlamentari. Clotilde Bertoni ricostruisce abilmente la rete che, fra cronaca e narrativa, venne tessuta intorno al caso della Banca Romana, fra il 1892 e il 1894, rendendolo emblematico: «Romanzo di uno scandalo», dal Mulino
Francesco Benigno Alias Domenica 25.3.2018, 6:00
«Dai cieli d’Italia in quei giorni pioveva fango (…) Tutte le sere, tutte le mattine, i rivenditori di giornali vociavamo per le vie di Roma il nome di questo o di quel deputato al Parlamento nazionale, accompagnandolo con lo squarciato bando ora di una truffa ora di uno scrocco a danno di questa o di quella banca (…) Torbida, fetida alluvione di melma su cui svolazzavano stridendo neri uccellacci, il sospetto e la calunnia». Queste parole di Luigi Pirandello (tratte da I vecchi e i giovani si riferiscono agli anni tra il 1892 e il 1894, il periodo dello scandalo della Banca Romana, il più rilevante della storia d’Italia prima di Tangentopoli.
 Fu una vicenda di enormi malversazioni, ora ripercorsa con eleganza da Clotilde Bertoni in Romanzo di uno scandalo La banca romana tra finzione e realtà (Il Mulino, pp. 382, euro 29,00). L’autrice, studiosa di letteratura, non si limita a fornirci qui una puntuale cronaca dei fatti, ma indaga il modo in cui lo scandalo è stato rappresentato in un particolare genere letterario, il romanzo parlamentare; e attraverso ciò come esso sia diventato emblema dei guasti del sistemo politico italiano.
Fu una vicenda di enormi malversazioni, ora ripercorsa con eleganza da Clotilde Bertoni in Romanzo di uno scandalo La banca romana tra finzione e realtà (Il Mulino, pp. 382, euro 29,00). L’autrice, studiosa di letteratura, non si limita a fornirci qui una puntuale cronaca dei fatti, ma indaga il modo in cui lo scandalo è stato rappresentato in un particolare genere letterario, il romanzo parlamentare; e attraverso ciò come esso sia diventato emblema dei guasti del sistemo politico italiano.
Spiegazione del buco
Tutto ebbe inizio con una trama, ovvero con il tentativo di un uomo politico di lungo corso come Giovanni Nicotera di allontanare dalla direzione generale del Banco di Napoli il senatore Gerolamo Giusso, suo fiero avversario. A tal fine fu disposta un’inchiesta su tutti e sei gli istituti bancari che avevano licenza di emissione, vale a dire che possedevano la facoltà di stampare banconote. L’indagine, affidata al senatore veneto Giuseppe Giacomo Alvisi, fece emergere varie irregolarità ma soprattutto rivelò una situazione assai critica alla Banca Romana, in cui un grosso ammanco di cassa (nove milioni) era stato artificiosamente ripianato con banconote «duplicate», ristampando cioè cartamoneta già emessa.
 Al timone della Banca Romana era da tempo un commerciante fattosi banchiere, Bernardo Tanlongo. Vedovo, cattolicissimo, padre di numerosa prole, di costumi frugali e quasi austeri, questi ostentava, insieme a un italiano incerto e a un tratto paternalistico, la radicata propensione al clientelismo e una spiccata capacità di addensare vaste reti di interessi, che includevano il Vaticano e la Casa Reale.
Al timone della Banca Romana era da tempo un commerciante fattosi banchiere, Bernardo Tanlongo. Vedovo, cattolicissimo, padre di numerosa prole, di costumi frugali e quasi austeri, questi ostentava, insieme a un italiano incerto e a un tratto paternalistico, la radicata propensione al clientelismo e una spiccata capacità di addensare vaste reti di interessi, che includevano il Vaticano e la Casa Reale.
Oltre a ricoprire varie cariche pubbliche e a gestire numerose proprietà del Sovrano, Tanlongo aveva da poco curato la liquidazione della Banca Tiberina, proteggendo così gli interessi dei politici coinvolti e anche quelli di alcune note amanti di re Umberto I. La spiegazione del clamoroso ammanco è semplice: dopo aver finanziato largamente lo sviluppo immobiliare della Capitale egli non aveva saputo, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, governarne la successiva crisi.
Malgrado l’evidenza dei fatti e l’ammissione dei gravi reati finanziari commessi, la reazione del sistema politico, che era stato da lui ampiamente foraggiato, fu ergere un muro a sua difesa. Non solo la relazione di Alvisi fu annacquata ma, mentre veniva elaborato un progetto di estensione per sei anni del privilegio di emissione, Tanlongo – probabilmente su pressione del Re e forse per dotarlo di immunità parlamentare – venne addirittura nominato senatore.
Come nei migliori feilleuton, però, la vicenda, che pareva conclusa, ebbe uno sviluppo imprevisto. Malato e avvilito, ma non domo, Alvisi passò la sua inchiesta a un deputato patavino, tale Leone Wollenborg, chiedendogli di divulgarne il contenuto dopo la sua morte. Detto fatto: le carte giunsero così a una pattuglia di deputati di opposizione, radicali, repubblicani e socialisti, uomini come Matteo Renato Imbriani, Napoleone Colajanni e Felice Cavallotti. A seguito della denuncia pubblica avanzata da costoro in parlamento e ripresa con clamore dalla stampa, venne allora istituita una commissione parlamentare d’inchiesta. Malgrado la plateale chiamata a correo della classe politica da parte di Tanlongo («se precipito casco in buona compagnia»), l’indagine si concluse con le dimissioni del governo Giolitti e con il successivo arresto di Tanlongo e di vari altri amministratori.
Non mancarono gli episodi inquietanti (come la rivelazione dell’occultamento di importanti documenti da parte di personale di pubblica sicurezza), tragici (come la morte di crepacuore dell’inquisito deputato Rocco De Zerbi), o boccacceschi (come la vicenda del commendatore Vincenzo Cuciniello, già celebrato aiutante di Silvio Spaventa nella lotta alla camorra, che aveva rubato per soddisfare un’incontrollabile, senile passione per le donne).
Come conseguenza di tutto ciò dilagava nell’opinione pubblica la percezione che una stagione, quella gloriosa dell’eroismo risorgimentale, fosse irrimediabilmente finita; facendo spazio a un’epoca volgare, intrisa di meschina vita parlamentare e di corruzione.
Soprattutto si aprì a quel punto la guerra di tutti contro tutti e segnatamente tra Giovanni Giolitti e il suo successore al timone del governo, Francesco Crispi. Giolitti, per ritorsione, fece depositare in parlamento un misterioso plico contenente documenti compromettenti per il presidente del Consiglio, tra cui lettere personali di sua moglie che si diceva documentassero una relazione avuta col maggiordomo. La «macchina del fango» era entrata in azione.
Mentre Crispi sospendeva le camere, riconvocandole dopo sei mesi, si apriva il processo, che finì per scagionare del tutto gli inquisiti, sorvolando anche sui reati che avevano confessato. Lo scandalo della Banca Romana terminava così con uno scandaloso nulla di fatto.
Topoi narrativi
Si rafforzò così ancor più la risaliente sfiducia nella democrazia rappresentativa, riproposta ora con la nuova formula – destinata a lunga vita – di «questione morale», e in ciò furono fondamentali una serie di romanzi che ruotarono attorno allo scandalo.
Le attente pagine che l’autrice dedica a testi oggi poco noti – Le ostriche di Carlo Del Balzo, I corsari della breccia di Filippo Colacito, L’assalto di Montecitorio, di Ettore Socci – letti in comparazione con il Rome di Émile Zola, restituiscono il modo con cui la letteratura, nutrendosi della cronaca, corrobora e fissa i topoi su cui si costruiscono narrazioni collettive influenti. Alcuni di questi autori, come Socci e Del Balzo, erano stati politici e anche deputati in quegli anni. Ma i loro romanzi piuttosto che nutrirsi dell’esperienza personale, traendone spunti potenzialmente preziosi, ricalcavano in sostanza la vulgata corrente, utilizzando gli schemi narrativi in voga, ed eternando così l’immagine della classe politica come «grande ladreria».
L'universo si espande a una velocità superiore a quella prevista dal modello cosmologico vigente
Il carburante oscuro dell’Universo
Astronomia. L'espansione del cosmo è molto più veloce di quel che si pensava fino ad oggi. Il nuovo valore della costante di Hubble prevede nel tempo un allontanamento di pianeti e galassie: attraverso l’osservazione di otto Cefeidi, «astri faro», si è misurata una accelerazione maggiore
Piergiorgio Pescali Alias Domenica 4.3.2018, 0:03
 Da quando nel 1929 l’astronomo Edwin Hubble scoprì il redshift, lo spostamento verso il rosso della radiazione emessa dalle galassie, si è a conoscenza che l’Universo si sta espandendo. Gli astrofisici hanno cercato di quantificare la misura di questa dilatazione tentando di rispondere a due domande: l’Universo si espande con la stessa velocità o, invece, sta rallentando? Nel 1998 gli studi di Adam Riess, Brian Schmidt e Paul Perlmutter replicarono alle questioni con una terza, del tutto inaspettata, risposta: l’Universo continuava ad espandersi, ma con una accelerazione in costante aumento. La scoperta valse ai tre scienziati il premio Nobel per la fisica nel 2011.
Da quando nel 1929 l’astronomo Edwin Hubble scoprì il redshift, lo spostamento verso il rosso della radiazione emessa dalle galassie, si è a conoscenza che l’Universo si sta espandendo. Gli astrofisici hanno cercato di quantificare la misura di questa dilatazione tentando di rispondere a due domande: l’Universo si espande con la stessa velocità o, invece, sta rallentando? Nel 1998 gli studi di Adam Riess, Brian Schmidt e Paul Perlmutter replicarono alle questioni con una terza, del tutto inaspettata, risposta: l’Universo continuava ad espandersi, ma con una accelerazione in costante aumento. La scoperta valse ai tre scienziati il premio Nobel per la fisica nel 2011.
PER INTERPRETARE coerentemente la nuova teoria si introdusse, oltre alla materia ordinaria e alla materia oscura, una terza componente, una sorta di carburante che consentirebbe all’Universo di espandersi: la cosiddetta energia oscura. Questa nuova grandezza rappresenterebbe circa il 68,3% della materia che compone l’Universo (secondo la teoria della relatività di Einstein, energia e materia sono strettamente correlate e la massa non è altro che una forma di energia). Il restante 31,7% sarebbe composto dalla materia oscura (26,8%) e da quella barionica (4,9%), la materia che noi «vediamo» e con cui i nostri sensi interagiscono ogni giorno.
Nessuno ha una risposta su cosa sia energia e materia oscura. Sebbene illustri ricercatori come David L. Wiltshire dell’università neozelandese di Canterbury o Alexander Kashlinsky del centro di voli spaziali Goddard della Nasa, abbiano ancora perplessità in merito all’espansione, la gran parte del mondo scientifico avvalora la tesi secondo cui la dilatazione dell’Universo sia causata da un’energia la cui origine rimane sconosciuta e della cui entità è responsabile quella che viene chiamata costante di Hubble. Il valore della costante stabilisce la velocità di recessione delle galassie nel cosmo, ma il suo numero non è mai stato determinato con precisione. Sino a pochi giorni fa si assumeva che questo fosse 67,15 chilometri al secondo per ogni Megaparsec di distanza (km/s/Mps).
PER CAPIRE QUESTA UNITÀ di misura astronomica occorre spiegare che il Megaparsec corrisponde a 3,26 x 106 anni luce (3.260.000 anni luce) e, dunque, una galassia che dista dalla Terra 1 Megaparsec di allontana da noi alla velocità di 65 chilometri al secondo. L’unità di misura della costante di Hubble (km/s/Mps) implica che la velocità di allontanamento di un oggetto aumenta con l’aumentare della distanza dall’osservatore: una galassia distante 10 Megaparsec si allontanerà ad una velocità 10 volte maggiore rispetto a quella che si trova a 1 Megaparsec da noi ed una distante 100 Megaparsec si sposterà ad una velocità 100 volte maggiore.
Recentemente lo stesso Adam Riess che nel 1998 aveva condotto la ricerca sull’accelerazione dell’espansione del cosmo, ha annunciato i risultati di un nuovo studio durato quattro anni effettuato con il telescopio di Hubble della Nasa e l’osservatorio spaziale Gaia dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea. Per tutta la durata delle osservazioni e a distanza di sei mesi l’una dall’altra, Riess e la sua equipe dello Space Telescope Science Institute (STScI) e della Johns Hopkins University, di cui fa parte anche l’italiano Stefano Casertano, hanno misurato Variabili Cefeidi, stelle pulsanti la cui luminosità massima e minima varia in un tempo costante secondo periodi stabiliti. Grazie al telescopio di Hubble, Riess è riuscito a osservare Cefeidi nella Via Lattea distanti tra i 6.000 e i 12.000 anni luce dalla Terra, una distanza dieci volte superiore a quella misurata sino ad oggi. Una scommessa azzardata, visto che le oscillazioni luminose di Cefeidi così lontane equivalgono ad appena 1/100 di differenza di luminosità di un pixel di una macchina fotografica.
PER VINCERE QUESTA SFIDA la squadra di ricercatori ha sviluppato un metodo di scannerizzazione che «fotografava» la posizione della stella migliaia di volte al minuto ogni sei mesi, per i successivi quattro anni paragonandone la luce emessa con otto Cefeidi più vicine a noi. Osservando le stelle «faro» in diversi periodi dell’anno e da diversi punti dell’orbita terrestre, l’equipe è riuscita a tracciare una precisa misura della parallasse stellare che lascia adito a ben pochi dubbi: la costante di Hubble, risulta essere 73.45 ± 1.66 km/s/Mpc, un valore circa il 9% maggiore a quella misurata nel 2015 con il satellite Planck, dell’Agenzia Spaziale Europea. La differenza, è macroscopica in termini scientifici perché pone le basi per una revisione della fisica del nostro Universo.
LA PRIMA CONSTATAZIONE che è possibile dedurre è che la forza che lancerebbe le galassie lontano le une dalle altre espandendo così l’Universo, non sarebbe costante, ma assumerebbe valori diversi nel tempo. Questo ha portato i fisici e gli astronomi a congetturare nuove ipotesi sulla composizione del cosmo e sul suo destino futuro e finale.
Il nuovo valore della costante di Hubble segna un punto a favore della tesi del Big Rip (Grande Strappo) secondo cui l’accelerazione con cui il nostro Universo si dilata porterebbe, con il tempo, ad allontanare le galassie, le stelle e i pianeti gli uni dagli altri sino a rendere il nostro spazio completamente scuro e freddo. In un Universo del genere, in cui sarebbe impossibile osservare anche il minimo residuo di spostamento verso il rosso (redshift) derivato dal Big Bang, l’energia oscura sarebbe così elevata da prevalere su ogni altra forza riuscendo alla fine a strappare (Rip) la materia ordinaria nelle sue particelle elementari (fermioni, leptoni, bosoni).
NEL CAMPO DELLA RICERCA più strettamente legata al nostro mondo, la scoperta del team di Riess aprirebbe nuove idee su come possa essere definite la materia e l’energia oscura. Una possibile ipotesi è che, così come la materia ordinaria interagisce con la radiazione elettromagnetica, la materia oscura potrebbe essere soggetta a interazioni con particelle a noi invisibili come la radiazione oscura. Questa, a differenza delle parallele radiazioni elettromagnetiche ordinarie, interagirebbe solo con la gravità mediante nuovi tipi di particelle battezzate neutrini sterili per distinguerle dai neutrini attivi conosciuti nel Modello Standard, i quali, invece, interagiscono con le forze deboli.
Si potrebbe anche ipotizzare che la materia oscura, che ad oggi si pensa non abbia alcuna interazione con quella ordinaria, possa invece influenzare le particelle elementari del Modello Standard per creare un tessuto connettivo strettamente correlato che garantirebbe la vita dell’Universo.
Tutte queste ipotesi hanno già aperto le porte a nuove strade di ricerca scientifica che potrebbe portare a nuove e più profonde deduzioni nei modelli sino ad oggi approntati sino a rivedere scenari passati e futuri della vita del nostro Universo.
SCHEDA
Quando il gesuita e astronomo belga Georges Lemaitre espose, durante il Convegno di Solvay del 1927 a Bruxelles, la sua idea dell’atomo primigenio ad Albert Einstein, questi la considerò un’idea abominevole. In seguito lo stesso fisico tedesco si ravvide dell’errore quando Hubble dimostrò che le galassie si allontanano causando il famoso redshift, o spostamento verso il rosso. Oggi sappiamo che il nostro Universo, dal Big Bang è invecchiato di 13,8 miliardi di anni. Pochi istanti dopo il Big Bang si vennero a formare le particelle elementari, gluoni e quark e le quattro forze che comandano l’attuale Universo (interazione forte, debole, gravitazione e elettromagnetica) si separano. I primi atomi di idrogeno e elio cominciarono ad apparire dopo 380.000 anni, ma si dovette attendere un altro miliardo di anni perché questi atomi si unissero per formare le prime galassie e le prime stelle. Quando queste esaurirono il loro combustibile nucleare, vennero a prodursi gli elementi pesanti che permisero la formazione di pianeti. Ma come evolverà il nostro Universo? Le decine di ipotesi proposte dai ricercatori si possono grosso modo suddividere in tre soluzioni, anche se altre possibilità non si possono escludere a priori. Il Big Crunch prevede che, quando la forza di espansione dovuta al Big Bang si esaurirà, il cosmo subirà una contrazione che lo vedrebbe collassare in una singolarità a cui potrebbe seguire un nuovo Big Bang.
Il Big Freeze e il Big Rip contemplano un Universo in continua espansione sino a raffreddarsi a tal punto che, per il primo modello, tutta la materia verrebbe assorbita in buchi neri per evaporare nella radiazione di Hawking, mentre per il secondo l’energia oscura dilanierebbe tutta la materia sino a riportarla allo stato di particelle elementari. Vi sono anche teorie che prevedono spin-off dei precedenti modelli per presentare singoli Multiversi generati dai buchi bianchi di Hawking o frattali collegati tra loro da stringhe o brani in cui ogni Multiverso sarebbe governato da leggi fisiche differenti.
Virginia Woolf nello sguardo dei contemporanei
Risvolto
Virginia bocca sporca d'inchiostro. Virginia
ginocchia spigolose sotto la lampada e sigaretta nel bocchino. Virginia
madonna beffarda e regina di Bloomsbury. Virginia che danza attorno a
Vanessa come una libellula attorno a una ninfea. Virginia che prega
Léonard di fermare l'automobile all'incrocio del negozio di
antiquariato. Virginia su uno sgabello a conversare di Proust con un
libraio parigino. Virginia su una poltrona sfondata alla Hogarth Press.
Virginia umbratile e crepuscolare, Virginia depressa, Virginia spassosa,
Virginia corrente d'acqua adamantina. Virginia creatura completamente
poetica. "Virginia Woolf e i suoi contemporanei" è un'antologia di
confessioni, corrispondenze, racconti e brevi interviste raccolte nella
crepa fra bellezza e realtà - là dove Virginia Woolf, protesa dal verso
poetico, afferrava brandelli di vita quotidiana per trasformarli in
prosa. È un florilegio di memorie promiscue, ventisette in tutto - dal
«buon vecchio» T.S. Eliot all'Orlando/Vita Sackville-West, dai fratelli
Lehmann a E.M. Forster e Christopher Isherwood, alla nipote Angelica o
all'amica Barbara - che ricompongono il fiero profilo aquilino, quasi
ascetico, di una Virginia squisita e claustrale; la prepotente
sensualità del suo genio; la violenza critica della sua lingua;
l'impertinenza vorace della sua curiosità. Perché attraverso la voce
degli altri riemerga dal fondo di un fiume nei pressi di Rodmell la sua,
bassa e gutturale come un vecchio velluto rosso. La nuova edizione di
Virginia Woolfe i suoi contemporanei curata da Liliana Rampello è un
tributo umano a questa visionaria sperimentatrice, in guerra con il
mondo ma del mondo profondamente entusiasta, per ricostruire l'intima
stanza che Virginia reclamava tutta per sé. Una stanza in cui alla
scienza del lutto si sostituisce una disperata "joie de vivre" e in cui
l'atto della scrittura si trasforma nel tentativo di catturare la vita
stessa.
Un coccio e il profeta Isaia
La studiosa Eilat Mazar ha annunciato di avere trovato in scavi nei pressi del Muro del Pianto un piccolo reperto, risalente a 2700 anni fa, che sarebbe appartenuto al personaggio biblico
Avvenire Giorgio Bernardelli martedì 27 febbraio 2018
martedì 27 febbraio 2018
L'account Stefano G. Azzarà è stato bloccato su FB per una trentina di giorni: contatti alternativi
Su segnalazione di qualche permaloso "compagno", FB ha rimosso alcuni miei assai vecchi post, equivocandone l'ironia come trasgressione delle regole del social network, e mi ha bloccato per 30 giorni.
L'algoritmo, si sa, è stupido. Tutti noi dovremmo riflettere però sul modo in cui utilizziamo uno spazio privato che si è imposto come pubblico ma che continua ad essere privato.
L'algoritmo, si sa, è stupido. Tutti noi dovremmo riflettere però sul modo in cui utilizziamo uno spazio privato che si è imposto come pubblico ma che continua ad essere privato.
Rientra nel discorso sulla necessità di un portale nazionale, ecc. ecc.
Qui alcune alternative per contattarmi su FB (finché durano). Soprattutto, però, pensando a quanto sopra, consiglio di migrare pian piano anche su VKontakte, in modo di non perdere diritto di parola [SGA].
Qui alcune alternative per contattarmi su FB (finché durano). Soprattutto, però, pensando a quanto sopra, consiglio di migrare pian piano anche su VKontakte, in modo di non perdere diritto di parola [SGA].
https://www.facebook.com/giovanni.degregorio.501
https://vk.com/id468880182
La guerra tra bufale di professione e bufale artigianali si inasprisce in tempi di elezioni
La vera bufala delle fake news
Codici aperti. Si moltiplicano gli studi per comprendere quali fattori influenzino le opinioni politiche. Secondo alcune ricerche scientifiche, però, le echo chambers sarebbero sovrastimate
Andrea Capocci Manifesto 25.2.2018, 0:04
A giudicare dalle pubblicazioni scientifiche, si direbbe che anche il mondo della ricerca risenta del clima elettorale italiano: cresce di settimana in settimana il numero di studi su come le nostre opinioni politiche si formano e si diffondono nella società, e su cosa le influenzi. In realtà, le elezioni di quaggiù c’entrano poco o nulla e si tratta in primo luogo di una conseguenza della digitalizzazione del dibattito politico.
ABBANDONATE PIAZZE, giornali e talk show, la dialettica si è trasferita soprattutto sui social network e sul web con gran soddisfazione dei sociologi con il pallino dell’informatica. Il World Wide Web, Facebook, Twitter e compagnia, infatti, rappresentano una fonte di dati che fa impallidire gli strumenti della sociologia tradizionale, basata su interviste e questionari.
Basta un po’ di pratica con il coding e si possono ricavare in pochi minuti informazioni in tempo reale sulle discussioni virtuali in corso. Chi di noi presta poca attenzione alla privacy, infatti, permette a tutti di osservare l’attività che teniamo sui social networks: di quali temi ci piace discutere, a chi diamo i nostri «like» e chi a sua volta dà credito a noi. Informazioni preziosissime per i pubblicitari che così possono ottimizzare le loro campagne, ma è una manna anche per i ricercatori che possono mettere a punto modelli sociali, verificare e smentire ipotesi, fare previsioni su come si spostano le nostre opinioni.
In questo campo di battaglia si incrociano sociologi, ma anche statistici, informatici e neuroscienziati, matematici e fisici. Tutti sotto la benevola egida di Mark Zuckerberg e colleghi, i veri padroni del giocattolo. Sono solo a decidere su quali e quanti dati lasciare a disposizione dei curiosi e quanto le piattaforme siano neutrali rispetto alle azioni e alle opinioni degli utenti. Gli scienziati accettano le condizioni: piuttosto che tornare ai questionari, meglio accontentarsi delle briciole di Zuck.
Anche in questa comunità scientifica, le parole più alla moda sono «fake news» (cioè le bufale) e le «echo chambers» o «bolle di filtraggio», quelle comunità telematiche di utenti affini che scambiano informazioni solo per darsi ragione a vicenda. Non giratevi, parlano (anche) di noi.
UNA DELLE QUESTIONI che più agita i net-ricercatori riguarda proprio l’impatto politico di fake news e echo chambers nell’epoca della Brexit, di Trump e dei vari populismi europei. Nascono prima le bufale su Hillary Clinton o Donald Trump? In altri termini, ci si chiede se l’ascesa dei populismi sia una causa o una conseguenza della diffusione delle balle virtuali. Non è una domanda oziosa: a leggere le inchieste giudiziarie e giornalistiche, sembrerebbe che i destini di un Paese possano essere decisi da squadriglie di utenti e bot impegnati 24/7 a screditare avversari politici e a manipolare sistemi elettorali, contro cui scatenare orde di algoritmi a difesa del politicamente corretto. Ma davvero il successo di Trump & Co. dipende da Facebook?
L’ipotesi sembra smentita da una ricerca appena pubblicata sulla rivista Information, Communication and Society da parte di Elizabeth Dubois (università di Ottawa, Canada) e Grant Blank (Oxford Internet Institute). Si tratta di una «ricerca vecchio stampo», visto che i loro dati sono tratti dalle risposte di ben 14mila utenti da sette Paesi diversi a un questionario, seppur telematico. E chissà che i risultati contro-corrente non derivino proprio dal metodo di ricerca.
SECONDO L’ANALISI dei due ricercatori, il problema delle «bolle» è largamente sovrastimato. È vero che gli utenti si influenzano a vicenda e che i social sono frammentati in circoli autoreferenziali. Ma per capire quanto contino le echo chambers, concentrarsi su un solo mezzo di comunicazione può essere fuorviante. Basti pensare che gli utenti sotto i 34 anni dichiarano di utilizzare in media cinque social network diversi.
I CITTADINI PIÙ INTERESSATI alla politica, che sono i più influenti, sono anche quelli più «onnivori». Dubois e Grant usano un’espressione più diretta, «drogati politici», per indicare la dipendenza dalle informazioni degli utenti politicamente più impegnati. Questi accedono alle informazioni da diverse fonti e in questo modo sfuggono alle echo chambers. All’altro estremo, solo l’8% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato di utilizzare una sola fonte di informazione. In conclusione: le «bolle» esistono ma hanno un impatto limitato, perché gli utenti che influenzano di più le opinioni politiche sono quelli che se ne sottraggono meglio.
Anche secondo un’altra ricerca del neuroscienziato Jay Van Bavel (New York University) e della psicologa Andrea Pereira (università di Leida), la diffusione delle bufale segue, e non precede, l’identità politica. Nell’ultimo numero di Trends in cognitive sciences, i due pubblicano un’estesa rassegna sulla ricerca di neuroscienziati, psicologi, sociologi e filosofi intorno ai motivi per cui tendiamo a credere alle fake news. In sintesi, prendiamo per buone informazioni inaffidabili perché l’identità derivante dall’appartenenza politica prevale sul desiderio di verità. Succede anche a chi, normalmente, dimostra capacità di analisi superiori alla media. Quando, ad esempio, in un problema matematico si aggiunge una connotazione politica, le competenze logiche vengono meno: se la soluzione esatta contraddice il nostro credo politico il nostro cervello è prontissimo a scegliere una soluzione alternativa, anche se errata.
Per ribaltare il meccanismo, sostiene Van Bavel, si può aumentare l’incentivo a preferire l’accuratezza al bisogno di identità. Ad esempio, dando un valore economico alla verità. «Se state litigando – spiega – chiedete al vostro avversario: ‘vuoi scommettere?’. Quando ci sono 20 dollari in ballo, nessuno vuole essere smentito». Può funzionare. Allo stesso modo, se volete convincere qualcuno non insultatelo, perché questo rafforzerà il suo bisogno di identità.
PROPRIO ALL’EVOLUZIONE della politica americana nella transizione tra Obama e Trump è dedicata una terza ricerca pubblicata a febbraio sulla rivista Race and social problems da Luigi Leone e Fabio Presaghi, due psicologi della Sapienza di Roma. I ricercatori hanno analizzato i dati dell’American National Election Studies del 2012, un’indagine dettagliata basata su circa 6000 interviste di elettori. Leone e Presaghi hanno cercato una relazione tra lo sdoganamento del discorso razzista nel dibattito pubblico americano e la parabola del Tea Party, il movimento conservatore che si colloca alla destra del Partito Repubblicano su posizioni ultraliberiste.
L’ascesa di Trump ha coinciso con il declino del Tea Party, da cui proveniva il principale antagonista repubblicano di Trump, Ted Cruz. Ma tra le due destre americane, in fondo così simili, c’è davvero contrapposizione? Secondo le analisi statistiche di Leone e Presaghi, più che opporsi a Trump il Tea Party gli ha aperto la strada spostando l’elettore repubblicano su posizioni estremiste. L’elezione di Trump, dunque, non è affatto il risultato di un golpe, ma una naturale evoluzione di una tendenza profonda ma reale nella società americana.
Anche senza menzionare bufale ed echo chambers, Leone e Presaghi giungono a conclusioni in linea con le altre ricerche citate. Le bufale digitali non sono la spiegazione dell’ascesa del populismo, al limite un sintomo di dinamiche politiche terribilmente analogiche contro cui gli algoritmi non basteranno.
lunedì 26 febbraio 2018
Il richiamo della foresta antifascistista e centrosinistra: tutti vogliono andare "oltre PALP"
La manifestazione del 24 impone una pausa di riflessione. Tutti fanno a gara nell'andare già "oltre" PALP
La partecipazione di Rifondazione e del PCI-PdCI - assieme alla sinistra dirittumanista-imperiale di Boldrini e Fratoianni e a quella neoliberale di D'Alema e Bersani, - alla manifestazione antifascistista indetta dal PD tramite le sue propaggini ANPI, ARCI e CGIL, impone purtroppo una pausa di riflessione nell'ottimismo della volontà.
E' chiaro a questo punto che alla scelta dell'autonomia politica questi partiti sono arrivati obtorto collo e in mancanza di alternative più immediatamente appetibili. L'autonomia culturale, infatti, è ancora del tutto assente.
Dopo la manifestazione di Macerata hanno avuto l'opportunità per un salto di qualità, invece ragionano ancora nella logica delle alleanze e della riduzione del danno. E non sono assolutamente nelle condizioni di comprendere i conflitti principali sul tappeto.
Coerente con tradizionale subalternità governista è Rifondazione, che in piena campagna elettorale ha partecipato all'assemblea di Parte Costituente assieme a un pezzo di SEL, con l'obiettivo di riunificare la corrente bertinottiana.
Ma non si salva nemmeno il PCI-PdCI: due giorni prima avevo chiesto a diversi dirigenti cosa avrebbero fatto, lamentando l'errore di Rifondazione, e mi avevano detto che il loro partito non avrebbe aderito. Invece è stato subito risucchiato dal richiamo della foresta centrosinistra.
Non esistono sponde per l'unità dei comunisti dentro PALP. Chissà, anzi, che ne sarà di PALP. Se dovesse rimanere sotto il 3% ma soprattutto se dovesse superarlo [SGA].
La partecipazione di Rifondazione e del PCI-PdCI - assieme alla sinistra dirittumanista-imperiale di Boldrini e Fratoianni e a quella neoliberale di D'Alema e Bersani, - alla manifestazione antifascistista indetta dal PD tramite le sue propaggini ANPI, ARCI e CGIL, impone purtroppo una pausa di riflessione nell'ottimismo della volontà.
E' chiaro a questo punto che alla scelta dell'autonomia politica questi partiti sono arrivati obtorto collo e in mancanza di alternative più immediatamente appetibili. L'autonomia culturale, infatti, è ancora del tutto assente.
Dopo la manifestazione di Macerata hanno avuto l'opportunità per un salto di qualità, invece ragionano ancora nella logica delle alleanze e della riduzione del danno. E non sono assolutamente nelle condizioni di comprendere i conflitti principali sul tappeto.
Coerente con tradizionale subalternità governista è Rifondazione, che in piena campagna elettorale ha partecipato all'assemblea di Parte Costituente assieme a un pezzo di SEL, con l'obiettivo di riunificare la corrente bertinottiana.
Ma non si salva nemmeno il PCI-PdCI: due giorni prima avevo chiesto a diversi dirigenti cosa avrebbero fatto, lamentando l'errore di Rifondazione, e mi avevano detto che il loro partito non avrebbe aderito. Invece è stato subito risucchiato dal richiamo della foresta centrosinistra.
Non esistono sponde per l'unità dei comunisti dentro PALP. Chissà, anzi, che ne sarà di PALP. Se dovesse rimanere sotto il 3% ma soprattutto se dovesse superarlo [SGA].
Belpoliti: uno sguardo postmoderno sul terrorismo suicida che non sembra nominare l'unica spiegazione, l'imperialismo
Risvolto
Ci si può mettere nella testa di un giovane terrorista islamico e immaginare le ragioni che lo inducono a morire per uccidere? Questo prova a fare Marco Belpoliti in Chi sono i terroristi suicidi. Ripercorrendo gli ultimi terribili sedici anni, dall’epocale attacco alle Torri gemelle alle stragi che da allora si sono succedute, l’autore cerca di capire perché il martirio sia diventato un’attrattiva possibile per giovani uomini e donne: è la giovinezza, infatti, uno degli elementi che accomunano gli attentatori, sempre più spesso adolescenti, manipolati da predicatori più anziani di loro e indotti con la promessa del paradiso, di un’esistenza ultraterrena migliore, a sacrificare la loro vita per la causa della jihad islamica. Di questo gesto estremo, che sfugge al pensiero razionale, Belpoliti indaga le motivazioni recondite, annidate in un credo religioso o ideologico e pronte all’uso per quella parte di popolazione musulmana che, nelle periferie urbane di Londra, Parigi, Bruxelles, Nizza, vive un senso di inferiorità.
Chi sono i terroristi suicidi è un libro che, per inquadrare e scandagliare un fenomeno decisivo e traumatico del nostro tempo, mette in campo tutti gli strumenti del sapere a nostra disposizione: la letteratura (Albert Camus, Salman Rushdie, Michel Houellebecq), la storia, la psicologia sociale, la psicoanalisi, l’antropologia. Un libro scritto in modo chiaro e semplice, che dialoga con il lettore nello sforzo di comprendere quello che per noi occidentali è l’incomprensibile: morire per un ideale religioso.
L'antisemitismo in Europa negli anni Venti: "Da duemila anni" di Mihail Sebastian
Risvolto
Romania, anni Venti. L’antisemitismo è sempre più diffuso e violento. Il
protagonista, uno studente ebreo dell’Università di Bucarest, insieme
ai colleghi correligionari subisce quotidianamente angherie e soprusi,
un martirio che gli altri sposano quasi fosse un processo di redenzione,
mentre lui si sente intimamente antisionista eppure incapace di
rinnegare la propria religione. Questo insanabile dissidio interiore lo
induce al vizio. Il suo tempo trascorre infatti in lunghe passeggiate
solitarie e notti alcoliche che spartisce con rivoluzionari, fanatici e
libertini. Ed è attraverso il suo vissuto quotidiano e le conversazioni
con i suoi compagni di strada – il determinato marxista S.T. Haim, il
sionista Sami Winkler o il carismatico professor Ghita Blidaru – che
il protagonista ricerca il senso di un mondo che sta cambiando e
dell’oscurità che sta scendendo sul suo paese e minaccia di
distruggerlo.
Uscito per la prima volta nel 1934, il romanzo è una tragica
testimonianza dell’ascesa dell’antisemitismo in Europa. Un documento
inestimabile e un racconto doloroso su uno dei periodi più feroci della
storia europea che, in questi tempi oscuri di irragionevoli spinte
nazionalistiche, ci insegna a dare un senso al passato offrendoci un
ritratto dei molti volti dell’antisemitismo e provando a dare una
risposta all’inevitabilità dell’odio.
Le Lettere ai genitori di Claude Lévi-Strauss
Prima e dopo l’incontro con il pensiero selvaggio
Antropologi. Raccolte dalla moglie Monique, le missive dell’antropologo francese durante il servizio militare, poi dall’America: «Lettere ai genitori 1931-1942», dal Saggiatore
Enrico Comba Alias Domenica 22.4.2018, 6:00
Nessun evento memorabile, né rivelazioni straordinarie, piuttosto vicende estremamente banali di vita quotidiana, problemi e aspirazioni del tutto comuni nelle lettere scritte da Claude Lévi-Strauss tra il 1931 e il 1942 ai suoi genitori, dove si parla di condizioni della vita militare, della ricerca di un lavoro, delle difficoltà economiche o del desiderio di acquistare la prima automobile. Tuttavia, questi documenti raccolti e curati dalla moglie Monique, che ha condiviso con il grande antropologo quasi sessant’anni di vita, contribuiscono a farci comprendere meglio l’epoca che precede e segue immediatamente lo scoppio del secondo conflitto mondiale.
 Come osserva Monique Lévi-Strauss nella sua prefazione a queste Lettere ai genitori 1931-1942 (traduzione di Massimo Fumagalli, Il Saggiatore, pp. 422, € 37,00), esse ci permettono di scorgere «l’uomo che si nascondeva dietro allo studioso», sebbene manchi il fondamentale periodo trascorso in Brasile, tra il 1935 e il 1939, di cui tuttavia Lévi-Strauss ha lasciato numerosi ricordi in Tristi Tropici. Presi insieme, questi due testi si integrano a vicenda, andando a costituire una sorta di autobiografia della giovinezza e delle prime fasi della carriera intellettuale dell’antropologo francese.
Come osserva Monique Lévi-Strauss nella sua prefazione a queste Lettere ai genitori 1931-1942 (traduzione di Massimo Fumagalli, Il Saggiatore, pp. 422, € 37,00), esse ci permettono di scorgere «l’uomo che si nascondeva dietro allo studioso», sebbene manchi il fondamentale periodo trascorso in Brasile, tra il 1935 e il 1939, di cui tuttavia Lévi-Strauss ha lasciato numerosi ricordi in Tristi Tropici. Presi insieme, questi due testi si integrano a vicenda, andando a costituire una sorta di autobiografia della giovinezza e delle prime fasi della carriera intellettuale dell’antropologo francese.
La prima moglie
La prima parte del volume, dedicata al periodo precedente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, comprende le lettere inviate durante il servizio militare, nel settore «Artiglieria e Trasmissioni», da una caserma presso Strasburgo; ci sono inoltre, le missive inviate da Parigi, dove Lévi-Strauss era stato trasferito per lavorare al Ministero della Guerra (probabilmente grazie all’intervento di alcune amicizie politiche) e infine quelle da Mont-de-Marsan, una cittadina delle Landes (attuale Nuova Aquitania), dove aveva trovato un posto come insegnante di filosofia nel liceo locale.
È il periodo in cui compare, quasi improvvisamente, la figura di Dina Dreyfus, che sarebbe diventata nel settembre del 1932 la sua prima moglie. I due avevano studiato insieme filosofia alla Sorbona e condividevano la militanza politica socialista: partirono insieme nel 1935 per il Brasile e Dina, la cui presenza nella prima fase della carriera di Lévi-Strauss è stata molto più importante di quanto non appaia, svolse un ruolo non secondario nella organizzazione delle due spedizioni che li avrebbero portati nell’interno del Mato Grosso per visitare le popolazioni dei Caduveo, dei Bororo, e dei Nambikwara.
Molti probabilmente ricorderanno la fotografia sbiadita di Dina pubblicata in Tristi Tropici durante la spedizione etnografica, unica testimonianza della sua presenza. Eppure, sua è la firma dell’articolo con cui sul Journal de la Société des Américanistes venne annunciata, nel 1938, la futura missione etnologica condotta nell’interno del Brasile, a testimonianza del suo ruolo centrale nella progettazione. Una infezione agli occhi costrinse poi Dina a abbandonare la spedizione, e il matrimonio con Lévi-Strauss finì dopo il loro ritorno in Francia, dove Dina rimase anche dopo l’occupazione nazista.
La seconda parte del carteggio, la più interessante, riguarda le lettere spedite da Lévi-Strauss durante il suo soggiorno a New York, dal 1941 al 1942, dove si era trasferito per sfuggire al pericolo dell’occupazione tedesca, grazie soprattutto all’intervento di Alfred Métraux, antropologo francese che da tempo risiedeva e lavorava in America, e che si era molto impegnato per far sì che Lévi-Strauss venisse invitato presso la New School of Social Research di New York.
In molte lettere viene ricordata con riconoscenza l’attenzione prestata da Métraux, persona «di un’estrema gentilezza, (che) sembra volermi aiutare con ogni mezzo e in maniera del tutto disinteressata».
«La sua amicizia e la sua devozione – si legge ancora – nei miei confronti sono al contempo inspiegabili e commoventi». Fu lo stesso Métraux a proporre il nome di Lévi-Strauss per alcuni articoli da pubblicare sull’Handbook of South American Indians, opera curata dalla Smithsonian Institution e destinata a divenire un riferimento classico per gli antropologi interessati all’America meridionale. Lévi-Strauss fu subito consapevole dell’opportunità che gli veniva offerta: «Eccomi quindi certo di passare alla storia con un’opera che sarà probabilmente un’autorità per un secolo».
Tra Boas e Malinowski
La pubblicazione di quei contributi avrebbe aperto al giovane Lévi-Strauss le porte dell’antropologia americana, consentendogli di entrare in contatto con grandi personaggi dell’epoca, anche loro spesso presenti nelle lettere: Robert Lowie, Ralph Linton, Julian Steward, che dirigeva l’Handbook, e lo stesso Franz Boas, il «padre fondatore» dell’antropologia negli Stati Uniti, dove Lévi-Strauss incontrò anche Malinowski, del quale scrive: «è anziano, gentile, parla egregiamente il francese e non si trova bene negli Stati Uniti».
Figura, in queste pagine, anche la passione per la musica classica – fin dai tempi del servizio militare, quando il giovane Claude chiede ai genitori di procurargli un’edizione del Pelléas et Mélisande di Debussy, e una curiosa inclinazione per la cucina: entrambe sarebbero diventate temi importanti nell’opera dedicata allo studio dei miti. Qualche breve accenno, nelle lettere da New York, allude alle prime ricerche di Lévi-Strauss nel campo della parentela e dell’elaborazione logico-matematica, che saranno materia della tesi di dottorato, discussa a Parigi nel giugno del 1948.
L’influenza di Jakobson
La scelta dell’argomento e del metodo impiegati risentono molto dell’amicizia con un altro esule, il grande linguista Roman Jakobson, con cui imbastì una relazione fondamentale, sebbene nelle lettere ne compaia appena qualche traccia. Proprio nell’ultima, però, datata settembre 1942, si accenna al fatto che Lévi-Strauss, oltre a tenere i suoi corsi, era interessato «a seguire un eccellente corso di linguistica tenuto da uno dei miei colleghi, il quale mi fornirà, in questo campo, delle conoscenze indispensabili per il lavoro».
L’influenza di Jakobson fu effettivamente decisiva nella formazione del giovane studioso e, da lì a qualche anno, sarebbe stata fondamentale a informare quella prospettiva strutturalista che nel campo della antropologia sarebbe rimasta legata inscindibilmente al nome di Lévi-Strauss.
Iscriviti a:
Post (Atom)